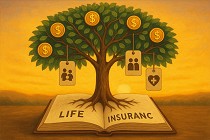Mutuo cointestato: come funziona, requisiti per averlo, calcolo pagamenti rate con esempi
Il mutuo cointestato Ť una soluzione per chi desidera condividere l'acquisto di una casa e le relative responsabilitŗ. Funzionamento, soggetti coinvolti, vantaggi, rischi in caso di insolvenza, aspetti fiscali e pratici esempi di rate

La richiesta congiunta di un finanziamento ipotecario è una scelta sempre più comune tra chi desidera acquistare una casa, in particolare coppie, conviventi o parenti. Per chi vuole comprendere a fondo le implicazioni contrattuali, diventa fondamentale capire come funziona un mutuo cointestato: vantaggi, rischi e obblighi condivisi con altre persone.
Cos'è il mutuo cointestato e come funziona
Un mutuo cointestato è un finanziamento in cui due o più soggetti sono contemporaneamente debitori nei confronti dell’istituto di credito per l’intero importo concesso. La peculiarità principale di questa soluzione è la responsabilità condivisa non solo per la propria quota, ma sull’intero debito. Questo comporta che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata da parte di uno dei richiedenti, la banca può rivalersi sull’altro cointestatario per l’intera somma residua.
In genere, la cointestazione riguarda coniugi o conviventi che intendono acquisire insieme la proprietà dell’immobile, ma sono ammesse anche altre combinazioni, come genitori e figli, o soci. L’intestazione simultanea comporta la somma dei redditi ai fini della valutazione del merito creditizio, incrementando così l’importo finanziabile e la probabilità di approvazione da parte della banca.
- Gli intestatari risultano obbligati verso la banca.
- La suddivisione interna delle quote può essere concordata liberamente, ma ciò non rileva per l’istituto di credito, che resta sempre tutelato rispetto all’intero debito totale.
Il contratto individua solitamente la quota di proprietà di ciascun soggetto sull’immobile, ma va ricordato che non è necessario essere sempre anche co-proprietari per sottoscrivere insieme un mutuo ipotecario. Infine, l’intero iter segue il Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), che disciplina gli aspetti contrattuali.
Requisiti, soggetti coinvolti e differenze con il garante
Per ottenere un mutuo intestato a più persone occorrono specifici requisiti:
- Documenti anagrafici: carta d’identità, tessera sanitaria, certificato di residenza e stato di famiglia di ogni richiedente;
- Documentazione reddituale: buste paga più recenti, dichiarazione dei redditi, estratti conto bancari;
- Valutazione positiva in termini di affidabilità finanziaria e creditizia.
Sul piano soggettivo, possono cointestare il finanziamento:
- Coniugi o conviventi
- Parenti, amici, soci
- Chiunque sia maggiorenne e abbia capacità giuridica
È importante chiarire la differenza tra cointestatario e garante. Il cointestatario è parte attiva del contratto, obbligato al pagamento e talvolta anche proprietario dell’immobile. Il garante, invece, interviene solo in caso di grave inadempimento, offrendo una garanzia sussidiaria e non diventando mai titolare dell’immobile stesso.
Vantaggi e svantaggi del mutuo cointestato
L’impiego di un finanziamento cointestato comporta numerosi vantaggi:
- Capacità di spesa più elevata: la somma dei redditi aumenta l’entità del prestito ottenibile;
- Accesso facilitato al credito: grazie alle maggiori garanzie per la banca;
- Possibilità di tassi d’interesse più competitivi: per via del rischio minore percepito dall’istituto di credito;
- Suddivisione dell’onere finanziario: i pagamenti possono essere organizzati internamente tra i cointestatari;
- Possibili agevolazioni fiscali legate all’acquisto della prima casa;
Non mancano tuttavia alcune criticità:
- Responsabilità solidale: qualunque cointestatario, in caso di inadempienza degli altri, può essere chiamato a corrispondere l’intero residuo;
- Difficoltà di uscita: separazione, divorzio o dissidi interni possono complicare la gestione del rapporto bancario;
- Accesso negato con cattivi pagatori: la presenza di un soggetto con precedente storia creditizia negativa può portare al rifiuto della pratica;
- Gestione della proprietà: quote poco chiare o non formalizzate rischiano di provocare controversie in fase di scioglimento del rapporto.
L’opportunità della cointestazione va attentamente bilanciata in base alle reali esigenze e condizioni delle parti coinvolte.
Responsabilità solidale, obblighi e conseguenze in caso di insolvenza
La responsabilità solidale è una delle nozioni più rilevanti nei contratti bancari cointestati, e implica che ciascun intestatario sia debitore verso la banca per l’intera somma residua del debito, a prescindere dalla suddivisione interna delle quote. Tale principio trova pieno riconoscimento negli articoli 1292 e successivi del Codice Civile.
- In caso di mancato pagamento anche da parte di uno solo, la banca può agire nei confronti di qualunque altro cointestatario per recuperare l’intero credito;
- Eventuali accordi tra i cointestatari, non opponibili all’ente mutuante, hanno senso solo nei rapporti interni e giuridicamente non tutelano rispetto al creditore;
Se uno dei debitori salda una somma eccedente la sua quota, può attivare un’azione di regresso verso gli altri intestatari per essere rimborsato di quanto dovuto oltre la propria parte. Se nessuno dei cointestatari paga, il creditore può attivare il pignoramento dell’immobile ipotecato, con il rischio concreto di vendita forzata all’asta.
Mutuo cointestato in caso di separazione, divorzio o rottura della convivenza
In caso di scioglimento dell’unione o della convivenza, i profili legati al finanziamento condiviso possono complicarsi notevolmente. Il vincolo solidale verso la banca resta in essere fino all’estinzione del debito, nonostante eventuali accordi tra le parti ormai separate.
- Se la proprietà dell’immobile era condivisa, occorrerà ridistribuire i diritti reali o procedere a una cessione della quota;
- Spesso si stipula un accollo interno: uno dei due ex partner si impegna a pagare la propria e l’altrui quota senza liberare l’altro verso la banca;
- Solo l’accollo liberatorio con esplicita adesione della banca svincola uno dei due soggetti dalla responsabilità sul debito rimanente;
- In caso di presenza di figli minori, l’assegnazione della casa familiare può incidere sulla gestione del debito e sulla ripartizione dell’onere di mantenimento.
In assenza di accordo o liberatoria, entrambi gli ex conviventi sono tecnicamente tenuti a rispondere delle rate residue e la banca può richiedere il pagamento a entrambi. Concordare in fase iniziale la gestione delle quote e formalizzare in modo preciso le condizioni di uscita è, pertanto, una prassi consigliata.
Acquisto, vendita e accollo: uscita dal mutuo cointestato
Le principali modalità per uscire dalla cointestazione di un finanziamento sono:
- Vendita dell’immobile: consente di estinguere in anticipo il debito con il ricavato della vendita e, in caso, dividere l’eventuale residuo tra i cointestatari;
- Affitto dell’immobile: soluzione temporanea qualora nessuno dei cointestatari voglia risiedere nell’immobile acquistato condividendo il pagamento rateale;
- Accollo liberatorio: un solo soggetto acquisisce la piena titolarità del bene e si assume l’onere di corrispondere tutte le rate residue. Occorre comunque la formale approvazione della banca, la quale valuta il merito creditizio del soggetto subentrante;
- L’accollo interno, invece, pur trasferendo l’obbligo all’interno della coppia, non solleva nessuno dei due da responsabilità verso la banca.
In assenza di liberatoria, il rischio di inadempienza persiste e potrà essere richiesto al cointestatario uscente il pagamento di somme che, nella pratica, potrebbero essere recuperate solo tramite azione legale di regresso verso l’obbligato effettivo.
Calcolo della rata e simulazioni pratiche
La determinazione della rata mensile avviene considerando:
- Importo richiesto, durata e tasso di interesse (fisso o variabile);
- Rapporto rata/reddito, che, secondo prassi bancaria, non deve superare il 30-35% dei redditi netti mensili complessivi dei cointestatari;
- Eventuali costi accessori, come spese di istruttoria e assicurazione.
| Simulazione n.1 | Mutuo da 200.000 euro in 25 anni, tasso fisso 3,5%: | Rata mensile: circa 1.000 euro (pari al 33% di un reddito netto di 3.000 euro/mese) |
| Simulazione n.2 | Mutuo da 150.000 euro in 30 anni, tasso variabile 3%: | Rata mensile: circa 630 euro (pari al 32% di un reddito netto di 2.000 euro/mese per ciascun cointestatario) |
Allungando la durata si può ottenere una rata minore, a fronte di un aumento della spesa complessiva per interessi. Il sistema del calcolo congiunto consente di ottenere un importo finanziabile più elevato, a patto di rispettare i limiti di esposizione considerati sostenibili per la somma dei redditi familiari.
Fiscalità e detrazione degli interessi passivi
In presenza di una cointestazione e se l’immobile è destinato a prima casa, ogni cointestatario può beneficiare della detrazione IRPEF degli interessi passivi e degli oneri accessori fino al 19% su un importo massimo complessivo di 4.000 euro annui. L’importo detraibile viene, tuttavia, suddiviso in proporzione alle quote di mutuo intestate. Se uno dei soggetti è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera detrazione può spettare al soggetto con maggiore capienza fiscale. Per approfondimenti normativi, si rimanda alle linee guida dell’Agenzia delle Entrate. In caso di vendita dell’immobile o estinzione anticipata, il diritto alla detrazione decade dalle annualità successive.
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra