
Quando un datore di lavoro mette ansia ad un dipendente? I casi con esempi concreti e cosa si può fare
Ansia sul lavoro causata dal capo? I casi in cui è possibile chiedere il risarcimento, dalle forme di mobbing allo stalking lavorativo
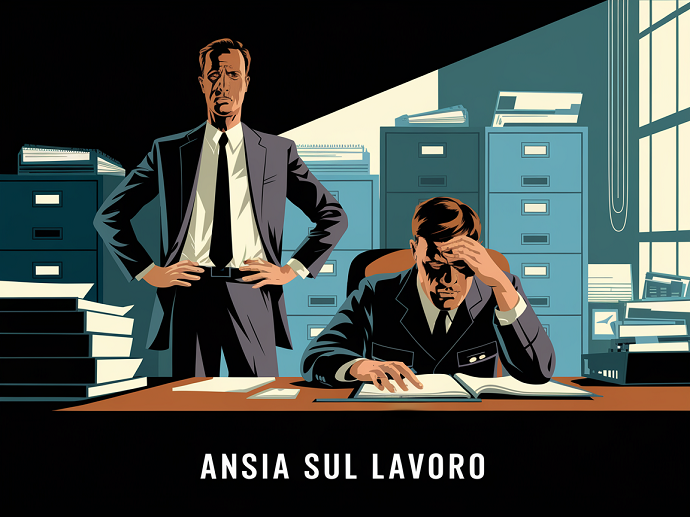
In alcuni contesti, la pressione eccessiva esercitata sull'ambiente lavorativo può trasformarsi in un problema concreto per la salute del dipendente, andando a intaccare l'integrità fisica e psichica del lavoratore. Questo problema è spesso legato a condotte che violano l’articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro di garantire condizioni lavorative che tutelino la persona del dipendente.
Tali situazioni comprendono, ad esempio, una gestione autoritaria e senza empatia, richieste sproporzionate rispetto alle capacità lavorative o continui comportamenti che generano insicurezza e pressione psicologica.
- Casi in cui è possibile chiedere il risarcimento per ansia al capo
- Come chiedere il risarcimento per ansia sul lavoro, requisiti e documentazione
Casi in cui è possibile chiedere il risarcimento per ansia al capo
Esistono diversi scenari in cui un lavoratore può richiedere il risarcimento al proprio datore di lavoro per ansia causata da comportamenti scorretti o negligenti. Tra questi, lo straining, caratterizzato da azioni stressogene ripetute che creano disagio psichico, pur in assenza di un chiaro intento persecutorio. Un altro esempio frequente è lo stalking lavorativo, dove atti come molestie, minacce o controlli ossessivi portano a uno stato di ansia grave e prolungato. Quando tali condizioni producono patologie diagnosticabili, è possibile configurare anche il reato di lesioni personali.
Straining, una forma attenuata di mobbing
Lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing, caratterizzata da comportamenti che creano un ambiente lavorativo stressante, pur in assenza di un intento persecutorio continuativo. Questa condotta si concretizza mediante atti sporadici o ripetuti che, a lungo termine, compromettono il benessere psicofisico del dipendente. L’elemento distintivo dello straining rispetto al mobbing risiede nella minor frequenza delle azioni ostili e nella mancanza di finalità di emarginazione sistematica del lavoratore.
La base normativa dello straining si rintraccia nell’articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute fisica e psichica del personale. Sebbene lo straining non sia definito specificamente dalla legge, è stato riconosciuto ampiamente dalla giurisprudenza come un illecito civile. Un esempio ricorrente può essere il mancato rispetto dei turni di riposo stabiliti per legge o la richiesta sistematica di mansioni straordinariamente impegnative senza reale necessità.
Tra i comportamenti tipici dello straining vi sono:
- l’attribuzione costante di compiti dequalificanti che sottovalutano le competenze del lavoratore;
- l’isolamento sistematico del dipendente dagli altri colleghi;
- l’omissione reiterata di comunicazioni importanti relative all’ambiente lavorativo, che lo escludono dalle dinamiche aziendali.
Per dimostrare lo straining, il lavoratore deve provare il nesso causale tra il comportamento del datore di lavoro e il danno psicologico subito. A supporto della denuncia, è fondamentale raccogliere documentazione medica, testimonianze di colleghi o altre evidenze che confermino le condizioni lavorative discriminatorie. In mancanza di tali prove, il rischio è che il comportamento venga interpretato come normale conflittualità all’interno di un ambiente lavorativo competitivo.
Stalking lavorativo, quando l'ansia diventa reato
Lo stalking lavorativo, noto anche come persecuzione occupazionale, supera l’ambito civile per configurarsi come un vero e proprio reato, disciplinato dall’articolo 612-bis del Codice Penale. Questo reato si verifica quando il datore di lavoro o un superiore attua condotte reiterate di minacce o molestie nei confronti di un dipendente, al punto da causare un grave stato di ansia, paura o alterazione delle sue abitudini di vita.
Le azioni che configurano stalking lavorativo possono manifestarsi attraverso:
- Controlli ossessivi: il lavoratore viene sorvegliato in modo costante, anche al di fuori dell'orario lavorativo, attraverso email, telefonate o persino pedinamenti.
- Minacce e ricatti: il datore promette licenziamenti immotivati o demansionamenti ingiustificati per creare un clima di paura.
- Molestie verbali: insulti, commenti offensivi o allusioni personali ripetute che generano insicurezza e disagio psicologico.
La peculiarità dello stalking lavorativo risiede nell’intenzione persecutoria, accompagnata da una reiterazione che va oltre il conflitto lavorativo ordinario, trasformandosi in una vera violazione della sfera emotiva e privata del lavoratore. Questo comportamento non solo compromette il benessere psichico del dipendente, ma causa anche danni gravi, come stati di ansia cronica, insonnia e depressione.
Lesioni personali, quando l'ansia diventa malattia
Quando l’ansia si intensifica diventando una vera e propria condizione patologica, si può configurare il reato di lesioni personali, disciplinato dagli articoli 582 e 590 del Codice Penale. In questo contesto, le lesioni non si limitano a danni fisici, ma includono anche disturbi psichici come stati di ansia cronica, insonnia o depressione, che compromettono le capacità di svolgere attività quotidiane o lavorative.
Nell’ambito lavorativo, queste situazioni derivano spesso da comportamenti che generano un clima lavorativo insostenibile, come pressioni psicologiche costanti, richieste di carichi di lavoro eccessivi, umiliazioni o discriminazioni reiterate.
Come chiedere il risarcimento per ansia sul lavoro, requisiti e documentazione
Per ottenere il risarcimento per ansia causata dall'ambiente lavorativo, è necessario fornire una documentazione adeguata, a supporto della propria richiesta. Il lavoratore deve dimostrare che il danno subito è una diretta conseguenza di comportamenti specifici del datore di lavoro o dell’organizzazione aziendale. Tale nesso causale deve essere chiaro e documentato.
Tra i requisiti troviamo:
- La presenza di un danno alla salute psicofisica, diagnosticabile attraverso certificazioni mediche rilasciate da professionisti qualificati, come psicologi o psichiatri.
- Il collegamento diretto tra il danno riportato e le condotte lesive del datore di lavoro, ad esempio molestie, pressioni eccessive o intimidazioni.
- L’assenza di condizioni lavorative adeguate a preservare l’integrità morale e fisica del dipendente, come previsto dall’articolo 2087 del Codice Civile.
Per quanto riguarda la documentazione necessaria, è fondamentale produrre:
- Certificati medici che attestino lo stato di ansia o gli altri disturbi riportati, preferibilmente rilasciati da strutture pubbliche o accreditate.
- Eventuali referti psicologici o perizie medico-legali che approfondiscano i disturbi sofferti e la loro origine.
- Email, comunicazioni o testimonianze di colleghi o collaboratori che confermino le condizioni lavorative deteriorate o le azioni del datore di lavoro.
La richiesta può essere avanzata tramite un’azione legale, di norma con il supporto di un avvocato specializzato in diritto del lavoro, che valuterà se intraprendere una causa civile o eventualmente anche un procedimento penale. È importante rispettare i termini di prescrizione previsti dalla legge per evitare la decadenza del diritto al risarcimento.
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra


