
La nuova repubblica tecnologica che si sta affermando negli Usa: che cosa, come funziona e i rischi
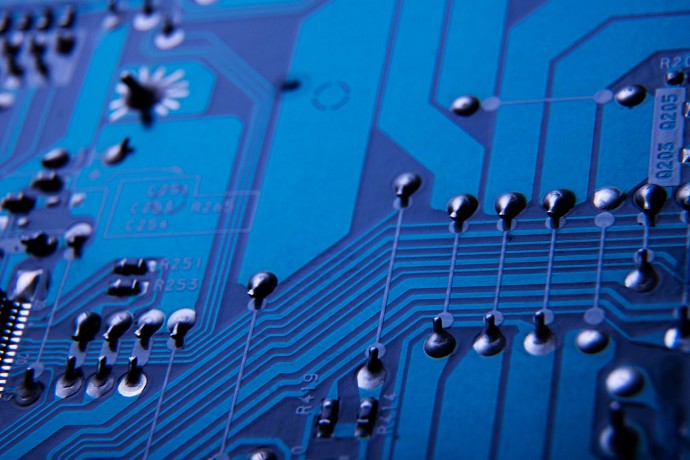
La repubblica tecnologica funziona attraverso un patto strategico tra Stato e imprese con i contratti federali, le commesse militari, i programmi di ricerca nazionale e i piani per l'AI.
La repubblica tecnologica che prende forma negli Stati Uniti non nasce da un improvviso atto politico, ma è il risultato di un lungo percorso che intreccia pensiero filosofico e visione manageriale. Figure come Gilbert Simondon, che vedeva nella tecnica un processo di individuazione capace di trasformare i rapporti sociali, e Gilles Deleuze, che interpretava la macchina come flusso di desiderio e produzione, hanno fornito un lessico che oggi viene riutilizzato da imprenditori e CEO per giustificare una nuova centralità della tecnologia nella vita collettiva. Non è casuale che il volume The Technological Republic di Alex Karp e W. Zamiska evochi un linguaggio che mescola filosofia e geopolitica, scienza dei dati e valori comunitari, costruendo un manifesto più politico che aziendale.
La Silicon Valley delle origini era raccontata come luogo anarchico, un mosaico di startup nate in un garage, spinte dal sogno di rompere l'ordine esistente e creare un futuro aperto. Oggi, la stessa area geografica è diventata cuore politico-industriale, integrato negli ingranaggi del potere federale. Non più solo laboratorio di innovazione, ma organo costituente di un ordine che si presenta come indispensabile alla sopravvivenza dell'Occidente. In questo slittamento simbolico, i CEO miliardari assumono un ruolo che ricorda più quello dei padri fondatori di una nuova repubblica che quello di imprenditori privati.
Il testo di Karp e Zamiska è rivelatore perché non proviene da ambienti della destra trumpiana, ma da un esponente dichiaratamente vicino al campo liberal-democratico. Il fatto che un simile linguaggio, incentrato su nazione, comunità e spirito occidentale, emerga in questo contesto significa che la narrazione della repubblica tecnologica è trasversale, capace di parlare a più constituency politiche. È proprio questa sua duttilità a renderla potenzialmente egemonica: un discorso che può essere radicalizzato a destra da figure come Peter Thiel o assorbito in chiave istituzionale da amministrazioni moderate.
Struttura e funzionamento del nuovo ordine
La repubblica tecnologica funziona attraverso un patto strategico tra Stato e imprese, dove i contratti federali, le commesse militari, i programmi di ricerca nazionale e i piani per l'AI sostituiscono i vecchi strumenti di mediazione politica. La Casa Bianca non si limita più a regolare il settore: convoca i grandi attori tecnologici, li rende partner di governo, e in alcuni casi ne adotta direttamente le piattaforme come infrastrutture pubbliche.
Il funzionamento della repubblica tecnologica si articola su tre assi principali: dollaro programmabile, infrastrutture dei dati e intelligenza artificiale applicata. Con il GENIUS Act, le stablecoin in dollari diventano legalmente inquadrate e riconosciute come strumenti di pagamento regolati, estendendo l'egemonia monetaria americana al mondo digitale. Sul fronte dei dati, l'integrazione tra agenzie pubbliche e aziende private come Palantir mostra come la sorveglianza predittiva e l'analisi su larga scala siano divenute strumenti normali di gestione sociale. Infine, i programmi di AI militare e civile trasformano gli algoritmi in armi politiche, capaci di plasmare anche servizi sanitari, amministrativi e giudiziari.
Al centro della repubblica tecnologica non vi sono istituzioni elettive, ma una costellazione di miliardari - da Elon Musk a Sam Altman, da Mark Zuckerberg a Larry Ellison - che non agiscono come semplici imprenditori, bensì come oligarchia informale capace di influenzare direttamente la politica. Le riunioni a porte chiuse alla Casa Bianca, le cene con presidenti e candidati, i tavoli di lavoro sulle priorità strategiche sanciscono l'ingresso di questa aristocrazia tecnologica nei luoghi simbolici del potere americano.
Sovranità digitale e dominio del dollaro
Sul piano internazionale, la repubblica tecnologica rafforza la sovranità americana legando pagamenti, infrastrutture e AI all'orbita del dollaro. Se le stablecoin in dollari diventano il mezzo preferito di regolamento globale, la dipendenza economica dall'America non si limiterà più alla finanza tradizionale, ma investirà anche la dimensione digitale, generando una nuova forma di imperialismo monetario.
Il discorso di Karp e di altri leader hypertech insiste sull'idea che l'Occidente sia un corpo ferito, minacciato dall'instabilità globale e dalla perdita di valori comuni. In questa cornice, la tecnologia diventa lo strumento per ricomporre l'unità, per ridare forma a un spirito collettivo. Non è solo geopolitica, ma una vera e propria retorica identitaria, che evoca comunità e missione storica, cercando di trasformare l'innovazione digitale in collante culturale.
Dietro questa narrativa, però, si nasconde un rischio: quello di un autoritarismo high-tech, che non ha bisogno di uniformi o piazze per consolidarsi, ma si esprime attraverso piattaforme, algoritmi e infrastrutture digitali. La capacità di modulare desideri, orientare consumi, anticipare bisogni e bloccare deviazioni costruisce una forma di potere invisibile, dolce ma penetrante, che può normalizzare comportamenti senza mai apparire coercitivo.
I rischi interni della repubblica tecnologica
La trasformazione delle piattaforme in infrastrutture politiche rende la sorveglianza onnipresente. Ogni interazione, ogni scambio, ogni flusso di dati può essere registrato, analizzato e trasformato in indicatore di rischio. Il prezzo da pagare è una lenta ma costante erosione delle libertà civili, sacrificata sull'altare della sicurezza e dell'efficienza.
La concentrazione di potere nelle mani di poche corporation espone a un pericolo ulteriore: la cattura regolatoria. Quando le stesse imprese che forniscono infrastrutture essenziali contribuiscono a scrivere le regole del gioco, la distinzione tra arbitro e giocatore si annulla. Lo Stato rischia di diventare cliente e alleato.
La sfida più sottile riguarda la gestione del desiderio collettivo. La repubblica tecnologica non controlla soltanto risorse materiali, ma modella le condizioni stesse in cui un desiderio può nascere o essere represso. Gli algoritmi che selezionano notizie, i sistemi che orientano consumi, le piattaforme che definiscono interazioni sociali diventano macchine di normalizzazione. Il rischio non è solo economico o politico, ma antropologico: la riduzione della pluralità dei desideri a funzioni di un organismo collettivo predefinito.
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
