
Che cos'è il burnout sul lavoro, quali sono i sintomi e quali sono i diritti per i lavoratori colpiti
Il burnout lavorativo, riconosciuto sempre più anche in Italia, si manifesta con sintomi specifici e ha gravi ripercussioni sulla salute e sullo svolgimento delle mansioni: cause, diritti e strategie di prevenzione
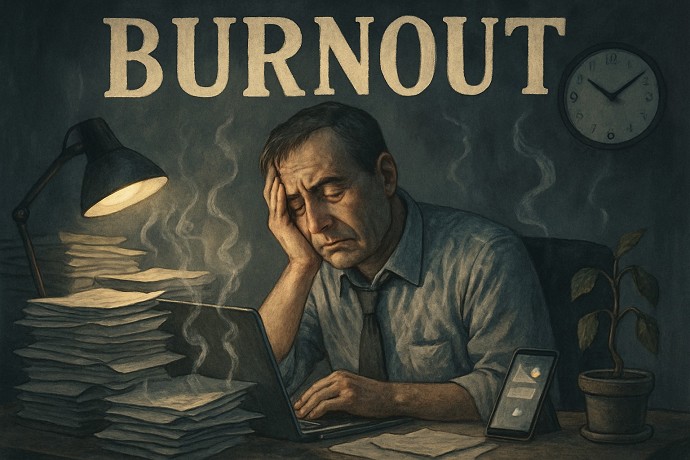
La sindrome di burnout sul lavoro è considerata oggi una delle principali emergenze psicologiche della forza lavoro in Italia. Si tratta di una condizione in costante crescita, attestata dai più recenti dati nazionali che evidenziano come quasi un lavoratore su tre abbia vissuto sintomi riferibili a questa sindrome nel corso della carriera. In un mercato del lavoro segnato da pressione crescente, carichi emotivi e richieste performative spesso insostenibili, la consapevolezza delle conseguenze del burnout ha assunto una centralità inedita sia per la salute dei lavoratori che per la produttività aziendale. In parallelo, la normativa italiana e le istituzioni europee riconoscono lo stress lavoro-correlato tra i rischi psicosociali da monitorare attentamente, sottolineando l'urgenza di tutela e prevenzione.
Cos’è il burnout: definizione, origine e differenze con lo stress
Il termine burnout indica uno stato di esaurimento psicofisico che si manifesta quando lo stress occupazionale da cronico e gestibile diviene patologico e duraturo. Formalmente, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha incluso questa sindrome nell’ICD-11 come fenomeno associato esclusivamente al contesto lavorativo, distinto dalle patologie mediche vere e proprie. Burnout significa letteralmente “bruciato”, a sottolineare la perdita progressiva delle energie fisiche ed emotive causata da condizioni lavorative logoranti.
La storia scientifica del burnout affonda le radici negli studi americani degli anni ‘70: le psicologhe Christina Maslach e Susan Jackson individuarono tre dimensioni tipiche del fenomeno:
- Esaurimento emotivo: percezione di energie prosciugate, spossatezza persistente e difficoltà di recupero.
- Cinismo o depersonalizzazione: distacco emotivo dal lavoro, atteggiamento apatico o ostile verso colleghi o utenti.
- Ridotta efficacia professionale: crescente insoddisfazione per i risultati e perdita di fiducia nelle proprie capacità lavorative.
È fondamentale distinguere burnout da normale stress lavorativo. Lo stress infatti può essere episodico, legato a particolari periodi di pressione, spesso risolutore e, entro limiti fisiologici, anche utile alla crescita professionale. Il burnout, invece, si sviluppa quando lo stress è continuo, non adeguatamente gestito o maturato in un ambiente lavorativo privo di supporti e risorse adeguate. A differenza dello stress reversibile, il burnout compromette motivazione, performance e soprattutto il benessere psicofisico globale. Lo stress tende a risolversi quando le pressioni diminuiscono; il burnout persiste e si aggrava anche dopo periodi di riposo, intaccando la sfera personale e sociale dell’individuo.
| Stress lavorativo | Burnout |
| Temporaneo, legato a specifiche situazioni | Cronico, si sviluppa gradualmente |
| Motivazione generalmente presente | Apatia, distacco e perdita di senso |
| Tende a risolversi col recupero | Persistenza della stanchezza e sintomi psico-fisici |
Fasi e sintomi del burnout, come riconoscere i segnali di allarme
La sindrome da burnout evolve progressivamente e riconoscere tempestivamente i suoi segnali caratteristici risulta imprescindibile per arginarne gli effetti.
- Fase dell’entusiasmo idealistico: il lavoratore manifesta inizialmente aspettative elevate e grande motivazione. Talvolta si assume carichi di lavoro superiori alle proprie forze, confidando nella gratificazione futura.
- Fase della stagnazione: l'entusiasmo si attenua, subentrano delusione, perdita di slancio e prime difficoltà a recuperare le energie. La routine prende il sopravvento.
- Fase della frustrazione: emergono manifesta insoddisfazione, senso di inutilità, isolamento emotivo, irritabilità e atteggiamenti difensivi verso colleghi e organizzazione.
- Fase dell’apatia e del disimpegno: si verifica il crollo motivazionale, con marcata perdita di interesse verso le mansioni e il contesto lavorativo. Si accentuano deficit cognitivi (calo della memoria e concentrazione), apatia e segni di disaffezione verso le relazioni personali e lavorative.
I campanelli d’allarme del burnout si esprimono su diversi livelli:
- Sintomi fisici: stanchezza cronica, disturbi del sonno, dolori muscolo-tensivi, cefalee, disturbi gastrointestinali, abbassamento delle difese immunitarie, alterazioni dell’appetito.
- Sintomi emotivi e mentali: umore depresso, perdita di autostima, ansia anticipatoria, scarsa soddisfazione, nervosismo e cinismo, crisi di pianto o rabbia.
- Sintomi comportamentali: calo della produttività, procrastinazione, scarsa cura dei compiti, assenteismo, isolamento sociale, maggiore conflittualità, abuso di sostanze o cibo “di conforto”.
Non tutti i sintomi compaiono insieme: spesso la progressione è subdola, con segni lievi e transitori seguiti dal peggioramento progressivo. Una parte dei soggetti riferisce la sensazione, che non si attenua con il riposo, di essere “svuotato” e di non riuscire più a provare motivazione né a ricavare soddisfazione lavorativa.
Cause e fattori di rischio: ambiente lavorativo e vulnerabilità individuali
Le origini del burnout sul lavoro riflettono una combinazione di fattori ambientali e personali. Le cause organizzative principali comprendono:
- Carichi di lavoro eccessivi e prolungati: richieste costanti superiori alle risorse disponibili, ritmi frenetici, orari imprevedibili o turni prolungati.
- Mancanza di controllo e autonomia: scarsa chiarezza dei compiti, impossibilità di prendere decisioni o carenza di strumenti adeguati per svolgere il lavoro.
- Clima lavorativo negativo: conflitti tra colleghi, assenza di supporto, mancanza di riconoscimenti, mobbing o pratiche scorrette nei confronti dei dipendenti.
- Scarso equilibrio tra vita lavorativa e privata: l’invasione degli impegni professionali nella sfera personale limita il recupero fisico ed emotivo.
- Insicurezza lavorativa: contratti precari, timori di licenziamento e assenza di percorsi chiari di carriera incrementano il rischio di cronicizzazione.
Fattori individuali di vulnerabilità sono il perfezionismo, la bassa resilienza allo stress, la tendenza all’autocritica, le aspettative irrealistiche e l’assenza di adeguate reti di supporto fuori dall’ambiente professionale. Non si tratta mai di “debolezza individuale”: la genesi del burnout è multifattoriale e spesso riflette squilibri oggettivi tra richieste e risorse a disposizione dei lavoratori.
Impatto del burnout, conseguenze sulla salute, sulle relazioni e sull’ambiente di lavoro
Le ripercussioni del burnout si manifestano su vari livelli. A livello fisico si riscontrano disturbi del sonno, indebolimento immunitario, cefalee, disturbi gastrointestinali, tensioni muscolari e maggiore vulnerabilità a patologie croniche (ad esempio, ipertensione o diabete tipo 2). Sulla salute mentale la sindrome si accompagna a quadri di ansia e depressione, senso di fallimento, perdita di fiducia in sé e crisi di identità professionale. Si rileva anche una maggiore incidenza di comportamenti auto-lesivi o dipendenze da sostanze.
Sul piano relazionale, chi soffre di burnout tende a ritirarsi dalla vita familiare e sociale, con peggioramento della qualità delle relazioni, esplosioni emotive apparentemente immotivate e sensazione di isolamento. Nell’ambito lavorativo, aumentano conflittualità, insoddisfazione, errori operativi e presenteismo inefficace. L'assenteismo, per malattia o demotivazione, risulta molto più frequente rispetto ai lavoratori non colpiti dalla sindrome.
Gli effetti sul sistema-azienda includono il calo della produttività, perdita di innovazione, aumento di turnover e costi diretti o indiretti (malattie, sostituzioni temporanee, formazione di nuovo personale). Secondo studi nazionali recenti, i costi complessivi associati a questa sindrome raggiungono 81 miliardi di euro annui in termini di assenteismo e riduzione di produttività.
Dati, settori e aree più colpite in Italia
L’incidenza del burnout in Italia mostra differenze rilevanti in base al settore, all’età e alla collocazione geografica. Secondo gli ultimi rapporti Censis e indagini cliniche, il 29-32% dei lavoratori italiani dichiara di aver vissuto sintomi compatibili con la sindrome, con picchi superiori tra le donne (fino al 51%) e nella fascia 25-34 anni.
I settori maggiormente esposti sono quelli in cui la pressione e la richiesta di coinvolgimento umano sono elevate:
- Sanità e assistenza sociale
- Retail e vendite
- Hospitality, turismo e tempo libero
- Insegnamento e pubblica amministrazione
- Forze dell’ordine e operatori sociali
Sul piano territoriale, metropoli come Bologna, Genova e Milano registrano livelli tra i più alti, rispettivamente con il 36%, 35% e 32% di lavoratori esposti. In generale, insoddisfazione per l’equilibro vita-lavoro, mancanza di supporto aziendale e precarietà risultano più marcati nelle grandi aree urbane.
Diritti dei lavoratori colpiti da burnout e tutele normative
Dalla prospettiva giuridica, burnout e stress lavoro-correlato rientrano tra i rischi psicosociali soggetti a valutazione obbligatoria e monitoraggio secondo il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), art. 28. Il datore di lavoro è obbligato a identificare, prevenire e ridurre i rischi, comprese le condizioni organizzative e ambientali che possono favorire l’insorgere di situazioni patologiche come il burnout. L’assenza di prevenzione configura responsabilità diretta del datore di lavoro sia civile che penale.
Sul piano assicurativo, la Circolare INAIL n. 71/2003 ha esteso la tutela alle “malattie da costrittività organizzativa”, riconoscendo, in casi specifici e documentati, il burnout come malattia professionale suscettibile di indennizzo, previo accertamento clinico e valutazione dell’occorrenza di nesso causale tra condizioni lavorative e sintomi riferiti dal lavoratore.
I lavoratori hanno diritto, se colpiti da burnout certificato, a periodo di astensione retribuita (malattia), tutele su postazione e orario, accesso prioritario a misure di supporto psicologico aziendale e, nei casi più gravi, al riconoscimento di inabilità temporanea o permanente. Le aziende sono obbligate a favorire la rieducazione professionale e il reinserimento del lavoratore.
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra

