
Quali sono i costi di gestione di una eredità e successione e quando conviene rifiutarla perchè si rischia di perderci
Quanto costa gestire la successione di una eredità e in quali casi è meglio rinunciarci
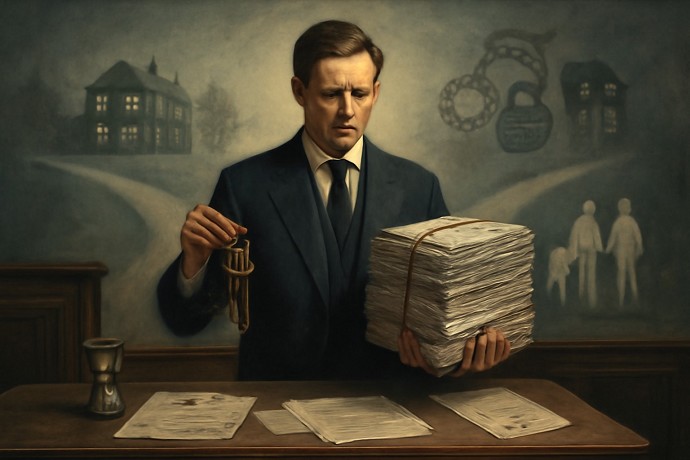
Affrontare una successione ereditaria significa dover valutare una molteplicità di aspetti economici, fiscali e giuridici potenzialmente onerosi.
Quando una persona viene designata come chiamata all’eredità, spesso si trova davanti a scelte complesse che possono incidere in modo importante sulle risorse personali e familiari. Non sempre ricevere beni e diritti rappresenta, infatti, un vantaggio reale.
Costi di gestione della successione: imposte, spese notarili e altri oneri
I costi legati alla successione di una eredità si articolano in diverse voci, che coinvolgono sia spese fiscali sia costi professionali e amministrativi, per quantificare in modo preciso l’impatto economico dell’eredità e valutare la reale convenienza dell’accettazione. Tra le principali voci di spesa si annoverano:
- Imposta di successione: Applicata in misura proporzionale al valore della quota ricevuta e in funzione del grado di parentela con il de cuius. Aliquote generalmente variabili dal 4% all’8%, con franchigie che arrivano a 1 milione di euro per coniuge e figli.
- Imposte ipotecarie e catastali: Dovute quando l’eredità comprende beni immobiliari, solitamente in misura fissa (200 euro ciascuna per gli immobili ad uso abitativo ereditati da parenti in linea retta).
- Spese notarili o legali: Necessarie per atti formali come redazione del testamento, dichiarazione di successione, volture catastali, specialmente se ci sono divisioni ereditarie o contestazioni.
- Costi di dichiarazione di successione: Includes bolli, diritti di copia, e/o parcelle quando si utilizzano servizi di professionisti abilitati.
- Oneri accessori e costi amministrativi: Marche da bollo, tributi speciali e spese per la presentazione e redazione di inventari.
| Tipo di costo | Importo indicativo |
| Imposta di registro per rinuncia o accettazione | 200 € (fissa) |
| Marca da bollo su atti | 16 € per ogni copia |
| Compenso notarile | Variabile (generalmente tra 500-1500 €), in base a complessità e valore |
| Imposte ipotecarie/catastali | 200 € ciascuna (successioni immobiliari) |
È importante sottolineare che alcune voci possono essere ridotte attraverso esenzioni o agevolazioni per soggetti con minori disponibilità o in presenza di clausole particolari.
Accettare o rinunciare all’eredità: valutazioni economiche e giuridiche
Prima di procedere con l’accettazione o la rinuncia, ogni chiamato all’eredità dovrebbe prima approfondire sia la posizione debitoria del de cuius che la natura dei beni ricevuti.
L’accettazione pura e semplice comporta l’assunzione di tutti i diritti e obblighi patrimoniali del defunto, quindi se il passivo supera l’attivo si rischia di danneggiare il proprio patrimonio personale. Un’analisi precisa deve quindi considerare:
- La presenza di eventuali debiti esistenti, tra cui mutui ipotecari, obbligazioni fiscali non assolte, fideiussioni, contenziosi pendenti.
- Lo stato e la regolarità di immobili (ad es. beni soggetti a vincoli, ipoteche, situazioni locative irregolari, necessità di interventi di sanatoria edilizia).
- L’esistenza di contenziosi o pendenze tra eredi che potrebbero dilatare costi e tempi di liquidazione.
- Il valore reale delle attività trasmesse comparato alle spese di successione e alle imposte dovute.
Quando conviene rinunciare all’eredità: debiti, immobili problematici e situazioni svantaggiose
La rinuncia all’eredità costituisce una scelta strategica in specifici contesti dove i rischi economici sono superiori agli eventuali benefici. Le principali situazioni in cui conviene rinunciare all'eredità per evitare di perderci sono:
- Presenza di debiti superiori ai beni: In caso di patrimonio passivo (debiti fiscali, bancari, obbligazioni pendenti, cartelle esattoriali) gravanti sull’asse ereditario, accettare significa farsi carico di passività anche con il proprio patrimonio personale.
- Immobili da regolarizzare o non produttivi: Beni immobili soggetti a vincoli, abbandonati, occupati abusivamente o su cui gravano ipoteche possono comportare costi di regolarizzazione, sanatorie, tasse eccessive o contenziosi che superano il valore degli stessi.
- Situazioni familiari conflittuali o contenziose: Divergenze insanabili tra eredi o presenza di cause in essere sulla divisione ereditaria rischiano di generare ulteriori spese legali e amministrative.
- Interessi personali o pianificazione differente: In determinati casi, la rinuncia viene considerata anche come strumento per consentire la devoluzione diretta a discendenti o altri familiari, soprattutto laddove il chiamato desideri tutelare altri soggetti.
Come si rinuncia all’eredità: procedure, tempi e documentazione necessaria
La rinuncia costituisce un atto formale, disciplinato dal codice civile, che deve rispettare regole precise per produrre effetti giuridici:
- Deve essere resa tramite dichiarazione espressa, in presenza di notaio o presso la cancelleria del tribunale competente nel luogo dove si è aperta la successione.
- Non è valido un semplice comportamento omissivo o una scrittura privata.
- Al momento della dichiarazione occorre presentare: documento d’identità e codice fiscale dei dichiaranti, codice fiscale e certificato di morte del de cuius, eventuale testamento o autorizzazione del giudice tutelare se vi sono minori o incapaci.
- La rinuncia va registrata a cura del cancelliere o del notaio presso il registro delle successioni comunale.
I termini previsti sono ampi: ci sono generalmente 10 anni dall’apertura della successione per rinunciare e in questo caso i costi sono relativamente contenuti e principalmente legati a imposta di registro, marche da bollo e diritti di cancelleria; la redazione tramite notaio comporta costi maggiori rispetto alla procedura in tribunale.
Precisiamo che una volta che si rinuncia ad una eredità, nulla vieta di ripensarci e accettarla, sempre secondo condizioni e procedure ben definite.
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
