
Se i figli rinunciano all'eredità chi subentra secondo leggi 2025?
Come cambia la divisione delleredità se i figli vi rinunciano: cosa prevedono le leggi in vigore tra quote legittime e percentuali spettanti
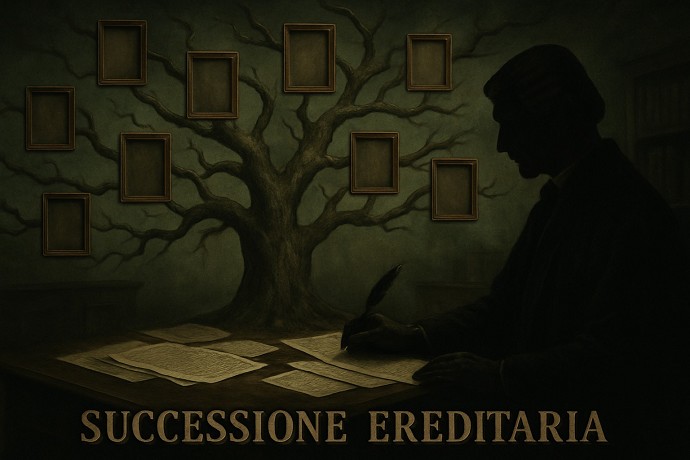
Nel panorama delle successioni ereditarie in Italia, una delle questioni più discusse e fonte di dubbi riguarda chi subentra quando i figli rinunciano all'eredità di un genitore. La normativa nazionale, disciplina con precisione le regole, le procedure operative e il percorso di subentro, con lo scopo di tutelare sia i legittimari sia i chiamati successivi.
Sistema delle successioni, tipi e principi normativi
La successione ereditaria si suddivide in tre principali categorie:
- Successione testamentaria: regolata da un testamento, in cui il defunto (de cuius) stabilisce la ripartizione dei beni patrimoniali.
- Successione legittima: interviene in assenza di testamento e segue l’ordine e le quote stabiliti dalla legge (Codice Civile, artt. 565 e seguenti).
- Successione necessaria: tutela specificamente i cosiddetti legittimari (coniuge, figli, ascendenti), ai quali la legge riserva comunque una parte (quota legittima) anche contro la volontà testamentaria contraria.
L’intero impianto normativo si basa su principi di trasparenza, tutela del patrimonio familiare e rispetto dell’ordine di chiamata. In presenza di figli e coniuge superstite, la legge prevede una suddivisione delle quote ereditarie prioritaria rispetto ad altri possibili eredi.
Chi subentra se i figli rinunciano all’eredità
Se uno o più figli del de cuius scelgono di rinunciare formalmente all’eredità, la normativa vigente prevede diversi scenari, regolati principalmente dagli articoli 467, 468 e 521 del Codice Civile.
- Discendenti diretti del rinunciante (nipoti del de cuius): in assenza di volontà testamentaria contraria, subentrano tramite il meccanismo della rappresentazione, assumendo il diritto di decidere se accettare o meno l’eredità nella quota che sarebbe spettata al genitore rinunciante.
- Assenza di discendenti: se il figlio che rinuncia non ha figli o discendenti, la quota viene ridistribuita tra gli altri figli o coeredi. In assenza di questi, saranno chiamati gli ascendenti (genitori e nonni del defunto), i collaterali (fratelli, sorelle), fino al sesto grado, e infine lo Stato, secondo la scala di priorità stabilita dall’articolo 565 c.c.
La rappresentazione successoria permette dunque la trasmissione verticale del diritto successorio, garantendo continuità familiare e rispetto delle linee di stirpe. Si evidenzia la particolarità per cui la rappresentazione opera anche nei casi di premorienza, indegnità, assenza o decadenza dall’accettazione. Se anche i discendenti rinunciano, lo stesso meccanismo si ripete “a cascata”.
Rinuncia all’eredità, effetti e procedura formale
La rinuncia all’eredità ha l’effetto di escludere il rinunciante da qualsiasi diritto e obbligo patrimoniale sia attivo che passivo, con carattere retroattivo. Il soggetto viene considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. La procedura, aggiornata alle più recenti regole (anno 2025), prevede:
- Deposito di apposita dichiarazione scritta presso un Notaio oppure presso il Cancelliere del Tribunale competente per territorio (luogo di apertura della successione).
- Presentazione di documentazione: documento di identità valido, codice fiscale personale e del defunto, certificato di morte, eventuale copia del testamento, certificato di residenza del defunto.
- Registrazione dell’atto presso l’Ufficio delle Entrate.
Per i soggetti incapaci (minori, interdetti), la rinuncia richiede l’autorizzazione preventiva del giudice tutelare. In caso di accettazione tacita (ad esempio, vendita di un bene ereditario), la facoltà di rinunciare decade.
Termini: la rinuncia può essere effettuata entro dieci anni dall’apertura della successione. Tuttavia, se il chiamato è già nel possesso dei beni, è necessario procedere all’inventario entro tre mesi e manifestare la volontà di rinunciare nei quaranta giorni successivi.
Conseguenze e scenari pratici della rinuncia, rappresentazione e accrescimento
Le conseguenze principali della rinuncia da parte dei figli si distinguono secondo i seguenti meccanismi:
- Rappresentazione: i figli del rinunciante succedono direttamente al defunto nella quota spettante al genitore, secondo il principio della divisione per stirpe (art. 469 c.c.).
- Accrescimento: se non vi sono discendenti o altre persone idonee alla rappresentazione, la quota si accresce a favore degli altri coeredi di pari grado.
- Chiamata degli eredi successivi: in mancanza di ascendenti o discendenti idonei, si procede secondo l’ordine di successione legittima (collaterali, altri parenti sino al sesto grado, Stato).
Ciò comporta che, per evitare il rischio di subentro nei debiti del defunto, anche i discendenti “rappresentanti” devono eventualmente rinunciare a loro volta, secondo la prassi successoria.
Successione con testamento e sostituzione dell’erede
Negli ordinamenti testamentari, il testatore può prevedere sostituzioni specifiche in caso di rinuncia di uno o più eredi (art. 688 c.c., sostituzione ordinaria). In assenza di indicazioni, si applicano le stesse regole della successione legittima. Il testatore può inoltre indicare soggetti diversi da parenti (sostituzione volgare) rendendo necessaria una attenta verifica del testamento.
Se tutti i soggetti chiamati (ed eventuali sostituti) rinunciano, si fa ricorso, laddove previsto, alla rappresentazione o all’accrescimento.
Motivazioni e implicazioni della rinuncia all’eredità
I motivi per cui un figlio rinuncia all’eredità possono essere molteplici:
- Eccedenza dei debiti rispetto ai beni: il caso più frequente, per evitare che i creditori possano agire sul patrimonio personale del chiamato.
- Ragioni personali, relazionali o morali: inasprimento dei rapporti familiari precedenti, desiderio di devolvere il patrimonio in beneficenza, oppure volontà di favorire altri famigliari (nipoti).
- Strategie di protezione patrimoniale: evitare il coinvolgimento di beni personali in dispendiose situazioni debitorie.
In ogni caso, è opportuno valutare l’accettazione con beneficio di inventario (art. 490 c.c.), che consente di separare il patrimonio personale da quello ereditario, limitando la responsabilità solo fino all’attivo ereditario.
Costi e aspetti pratici della rinuncia
La rinuncia comporta costi fissi in termini di imposte di registro (200 euro) e bolli (45-60 euro circa). La parcella del notaio può variare in base alla complessità della pratica. In Tribunale, il costo è generalmente inferiore alla prestazione notarile, ma i tempi possono essere più lunghi.
Per la rinuncia da parte di minori, l’iter prevede la richiesta di autorizzazione al giudice tutelare e, in situazioni debitamente motivate, la dimostrazione che la decisione non sia dannosa per il minore.
FAQ – Domande frequenti sulla rinuncia all’eredità e subentro
- Se tutti i discendenti e i parenti più prossimi rinunciano, chi acquisisce l’eredità?
In assenza di altri chiamati legittimi e di disposizioni testamentarie specifiche, l’eredità viene devoluta allo Stato, che ne assume la proprietà ma senza dover rispondere dei debiti condizionati all’attivo patrimoniale. - Si può revocare la rinuncia?
Sì, finché la quota non sia acquisita da altri e non sia prescritto il termine decennale. La revoca avviene mediante atto pubblico o comportamento concludente. - Esistono casi di rinuncia parziale?
No. La rinuncia all’eredità deve riguardare tutta la quota spettante al chiamato. La legge non ammette rinunce parziali o condizionate. - Cosa succede ai debiti dell’eredità se si rinuncia?
Il rinunciante è considerato come mai chiamato e, pertanto, nessun creditore può agire nei suoi confronti per le posizioni debitorie del de cuius. - I creditori del rinunciante possono opporsi?
Sì, ma solo nei limiti della loro esposizione e tramite specifica istanza giudiziale per essere autorizzati ad accettare l’eredità in nome e per conto del debitore chiamato.
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra