
Riforma costituzionale della giustizia approvata, cosa cambia con separazione delle carriere e nuovi organi disciplinari
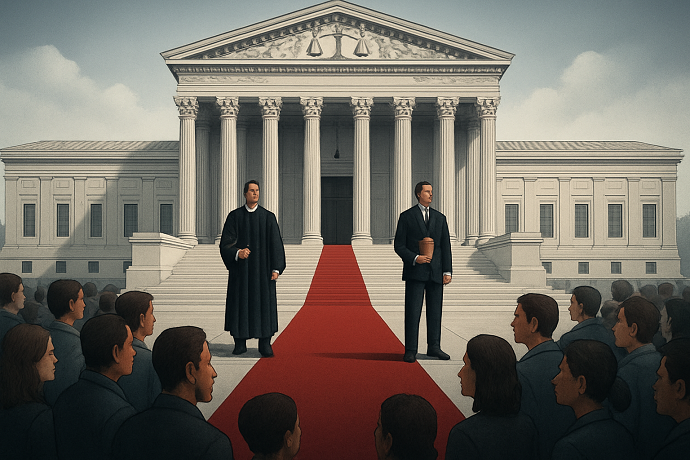
La recente riforma costituzionale della giustizia rivoluziona il sistema italiano: separazione delle carriere e nuovi organi disciplinari. Analisi delle reazioni e delle prossime tappe.
L’approvazione della riforma costituzionale della giustizia rappresenta uno dei passaggi più rilevanti per l’ordinamento nazionale degli ultimi decenni. Con il voto definitivo avvenuto oggi, l’Italia si prepara ad affrontare una fase di profondo rinnovamento del sistema giudiziario. L’intervento legislativo nasce all’interno di un contesto segnato da anni di dibattiti sul rapporto tra magistratura, potere politico e autonomia dei diversi attori giudiziari.
Nel contempo, viene data risposta a una richiesta di maggiore chiarezza sulle funzioni dei magistrati e di maggiore separazione tra le attività di indagine e giudizio.
Il provvedimento, promosso dal governo in carica, assume quindi una valenza storica per i suoi effetti su organizzazione, autonomia e controllo interno alla magistratura.
Iter parlamentare e approvazione della riforma
Il percorso istituzionale che ha portato all’approvazione della riforma è stato articolato e complesso. Il testo era stato presentato alla Camera per una prima lettura all’inizio del 2025, con successivi passaggi al Senato e una seconda lettura conforme nelle due Camere in base alle disposizioni dell’articolo 138 della Costituzione.
I dati finali del voto mostrano una netta divisione in Aula: 112 favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. I principali gruppi di centrosinistra e sinistra – Pd, M5s, Avs – si sono schierati contro il provvedimento, esprimendo dubbi in merito all’impatto sull’equilibrio tra poteri. Italia Viva ha invece optato per l’astensione, mentre Azione ha garantito il proprio sostegno alla maggioranza.
L’esame parlamentare non ha modificato il testo originario prodotto dall’Esecutivo, firmato dalla presidente del Consiglio e dal ministro della Giustizia.
Dopo il voto conclusivo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è previsto l’avvio della procedura per il referendum confermativo, in quanto la riforma non ha raggiunto la maggioranza dei due terzi. Questo passaggio segna sia la fine dell’iter nelle Camere sia l’inizio del coinvolgimento diretto dei cittadini, riflettendo lo spirito democratico previsto dalle norme costituzionali per le modifiche alla Carta.
Separazione delle carriere: cosa cambia per la magistratura
Al centro della riforma si trova la separazione delle carriere dei magistrati. L’obiettivo dichiarato della legge è quello di distinguere in modo strutturale i percorsi dei giudici e dei pubblici ministeri. Secondo quanto previsto, all’inizio della carriera ogni magistrato sarà chiamato a una scelta vincolante: appartenere alla funzione giudicante oppure a quella requirente, senza possibilità di trasferimento successivo.
L’attuale assetto della magistratura si fonda sull’articolo 104 della Costituzione, che sancisce l’autonomia dell’ordine giudiziario. La riforma aggiunge al testo la distinzione tra magistrati requirenti e giudicanti, ponendo fine al modello unitario. Nello specifico:
- Posizione del magistrato inquirente (pubblico ministero): responsabile delle indagini e della direzione dell’azione penale, distinto in modo definitivo dalla funzione giudicante.
- Posizione del magistrato giudicante: chiamato a esercitare la funzione giurisdizionale e a garantire l’imparzialità nelle decisioni, separato dal circuito investigativo.
- Vincolo di scelta iniziale: all’atto del concorso, il candidato magistrato sceglie la carriera di appartenenza e vi rimane per tutta la durata del servizio attivo.
I nuovi Consigli Superiori della Magistratura e l’Alta Corte disciplinare
La revisione dell’assetto di autogoverno della magistratura è uno degli aspetti più innovativi del provvedimento.
Sono previsti due distinti Consigli Superiori della Magistratura, uno per la carriera giudicante e uno per la carriera requirente. Entrambi gli organi restano presieduti dal Presidente della Repubblica, facendo riferimento rispettivamente al primo presidente della Corte di Cassazione e al procuratore generale della Cassazione.
- Composizione: ciascun Consiglio è formato da un terzo di membri laici, individuati tramite sorteggio da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento, e da due terzi di membri togati estratti a sorte tra i magistrati con requisiti specifici.
- Durata: il mandato dei componenti è fissato in quattro anni e non rinnovabile immediatamente.
- Competenze: i Csm sono responsabili di gestione delle funzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e incarichi relativi ai magistrati appartenenti alla rispettiva carriera.
Le reazioni politiche e istituzionali: maggioranza e opposizione a confronto
L’approvazione della riforma ha suscitato reazioni accese sui diversi fronti politici. Nel centrodestra, la soddisfazione è stata espressa sia dal Governo che dai rappresentanti dei partiti di maggioranza. La presidente del Consiglio ha parlato di “passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini”, sottolineando il valore storico del voto.
Ancora più netta la posizione della Lega e di Forza Italia, che hanno confermato di considerare la separazione delle carriere un punto qualificante dell’azione politica, tanto da aver promosso iniziative pubbliche a sostegno della riforma.
Di segno opposto la reazione delle opposizioni. In Senato sono stati esposti cartelli con lo slogan “No ai pieni poteri”, accompagnando la votazione con proteste visibili contro la legge. Dal Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra sono arrivate critiche circa il rischio di indebolire il sistema di garanzie della magistratura e la capacità di controllo costituzionale.
Anche alcune formazioni centriste hanno espresso riserve pur non votando contro.
All’interno della magistratura, l’Associazione Nazionale Magistrati si è mostrata fortemente critica, paventando effetti negativi sull’indipendenza dell’ordine giudiziario e annunciando l’intenzione di continuare il dibattito durante la campagna referendaria.
Il referendum confermativo: tempi, modalità e possibili scenari
Il mancato raggiungimento della maggioranza parlamentare qualificata di due terzi rende necessario il ricorso al referendum confermativo, secondo le regole sancite dall’art. 138 della Costituzione. Il quesito referendario potrà essere richiesto da un quinto dei componenti di una Camera, da 500.000 elettori o da cinque Consigli regionali, entro tre mesi dalla pubblicazione della riforma in Gazzetta Ufficiale.
- Tempistiche previste: il voto popolare dovrebbe tenersi tra aprile e giugno 2026.
- Modalità: la consultazione non prevede un quorum di partecipazione, pertanto il risultato sarà valido indipendentemente dal numero di votanti.
- Scenari:
- In caso di esito favorevole, la riforma entrerà in vigore e sarà seguita dall’adozione delle leggi attuative entro i 12 mesi successivi, come richiesto dal provvedimento stesso.
- In caso di esito negativo, la modifica costituzionale decadrà e resterà in vigore l’attuale assetto normativo.
Prossimi passi: leggi attuative e impatto atteso sulla giustizia italiana
Con la pubblicazione della legge e lo svolgimento del referendum, la fase successiva sarà rappresentata dall’elaborazione delle leggi attuative.
Entro dodici mesi dall’estensione delle nuove norme, il Parlamento dovrà adottare i provvedimenti necessari a disciplinare i profili organizzativi, i criteri di selezione, le procedure disciplinari e il funzionamento dei nuovi organi previsti dalla riforma.
Nel periodo di transizione, si continueranno ad applicare le normative vigenti per evitare vuoti regolamentari. Secondo gli addetti ai lavori, le novità introdotte saranno destinate a incidere profondamente su equilibrio dei poteri, trasparenza e affidabilità del sistema giudiziario.
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra

