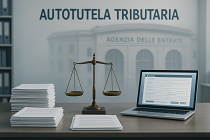Come si puņ fare ricorso contro l'alcol test: procedura, condizioni, tempi e cosa si deve dimostrare
Affrontare un ricorso contro l'alcol test richiede la conoscenza di normative, procedure, tempistiche e motivi validi di contestazione. Aspetti pratici, difensivi e le conseguenze amministrative e penali.

L’accertamento dello stato di ebbrezza tramite etilometro rappresenta uno dei principali strumenti utilizzati dalle autorità di polizia per garantire la sicurezza sulle strade. Tuttavia, possono sorgere situazioni in cui il risultato di tale controllo viene messo in discussione dal conducente, che valuta l’opportunità di presentare un ricorso contro alcol test.
La disciplina relativa è articolata e prende le mosse dall’art. 186 del Codice della Strada, integrato da successive disposizioni normative e sentenze giurisprudenziali, con implicazioni sia amministrative che penali a seconda dei casi. Il diritto alla difesa, la possibilità di far valere errori procedurali o tecnici, e la rilevanza delle più recenti decisioni della Corte di Cassazione, rappresentano aspetti centrali quando si intende avviare una contestazione. Comprendere a fondo le condizioni e le modalità con cui queste procedure possono essere attivate costituisce il presupposto per esercitare correttamente i propri diritti e tutelare al meglio la propria posizione legale.
Le conseguenze del rifiuto dell'alcol test: sanzioni amministrative e penali
Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico comporta l’attivazione di due procedimenti: uno amministrativo e uno penale. L’autorità che procede alla contestazione provvede immediatamente al ritiro della patente di guida, trasmettendola al prefetto che ne disporrà la sospensione, in genere per un periodo predeterminato. In questa fase, il soggetto è tenuto anche ad affrontare visite mediche presso la commissione locale per valutare la propria idoneità alla guida. Le conseguenze sono:
-
Sospensione della patente da sei mesi a due anni;
-
Arresto da sei mesi a un anno;
-
Confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione;
-
Revoca della patente in caso di recidiva nell’arco di due anni;
-
Decurtazione di 10 punti dalla patente.
In presenza di neopatentati, conducenti professionali o autisti di veicoli di particolare tipologia (autoveicoli oltre 3,5 t, autobus, taxi, ecc.) le sanzioni risultano più pesanti, con l’aumento di arresto e ammenda da un terzo alla metà. Non è necessario che il rifiuto sia esplicito: anche comportamenti elusivi o collaborativi insufficienti (ad esempio, insufficiente volume d’aria espirata nell’apparecchio) possono configurare la fattispecie di reato.
In presenza di patologie documentate che impediscano di eseguire correttamente l’esame, però, la difesa può articolare le proprie argomentazioni e puntare a un’assoluzione. Infine, la cassazione ha precisato che rifiutarsi di sottoporsi a prelievo ematico in ospedale dopo un incidente non costituisce reato se la persona non necessita effettivamente di cure mediche.
Per approfondire la disciplina sanzionatoria, consultare all’art. 186 del Codice della Strada.
Quali casi permettono di contestare l'esito dell'alcol test?
Gli esiti dei controlli con etilometro costituiscono una presunzione legale sullo stato di ebbrezza, ma non sono immuni da contestazioni. Un ricorso contro alcol test risulta possibile in presenza di elementi tecnici o procedurali che mettano in dubbio la regolarità dell’accertamento o il corretto uso dello strumento. È onere della difesa evidenziare malfunzionamenti, tarature scadute, errori nella doppia rilevazione, o mancate informazioni sulle garanzie difensive.
-
Mancata o irregolare omologazione/revisione dello strumento;
-
Anomalie tecniche certificate tramite analisi peritale;
-
Mancato rispetto delle procedure operative (doppio test, corretta sequenza delle rilevazioni, rispetto dei tempi tra una misurazione e l’altra);
-
Omissione dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (nei casi previsti dalla legge);
-
Situazioni mediche documentate che possano alterare i risultati del test.
Va ricordato che una contestazione generica o non documentata difficilmente sarà accolta. La dimostrazione dell’errore spetta alla parte che ricorre, supportata da prove concrete e consulenze tecniche.
Documentazione utile e onere della prova a carico della difesa
L’onere di dimostrare eventuali vizi del procedimento ricade integralmente sulla difesa. La richiesta della sola documentazione amministrativa non è sufficiente: occorre presentare prove o perizie tecniche che dimostrino l’anomalia nello strumento o nella sua utilizzazione. In termini pratici, l’accesso agli atti consente di raccogliere:
-
Verbale completo dell’accertamento;
-
Certificati di omologazione e di revisione/mantenimento dell’etilometro;
-
Manuali d’uso e rapporti tecnici dello strumento utilizzato;
-
Relazione di un consulente tecnico di parte sull’affidabilità e regolarità delle operazioni;
-
Documentazione sanitaria (eventuali patologie incidenti sulla capacità di eseguire l’esame).
La Cassazione - sentenza n. 28019 del 2025 - ha ribadito che una generica richiesta di verifica dello strumento non è sufficiente: occorre dimostrare, con fatti circostanziati, l’anomalia lamentata. Solo di fronte a contestazioni specifiche il giudice può ordinare un approfondimento istruttorio a carico della pubblica accusa.
Errori di procedura: mancato avviso di assistenza legale e rilevazioni irregolari
Due sono le principali irregolarità procedurali nel campo dei controlli con etilometro:
-
Omissione dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, secondo l’art. 114 disp. att. c.p.p. Questo vizio comporta la nullità del procedimento e può invalidare le sanzioni ove il test sia stato svolto senza tale garanzia;
-
Mancata esecuzione delle due misurazioni a distanza regolamentare, o rilevazioni effettuate fuori tempo massimo dopo l’incidente, costituiscono anomalie capaci di permettere il ricorso.
Le recenti linee interpretative della giurisprudenza sottolineano la necessità di rispettare le procedure come requisito per la validità dell’accertamento e della conseguente sanzione.
Strategie e modalità di presentazione del ricorso
L’approccio difensivo deve essere personalizzato e supportato da un’analisi dettagliata delle specificità del caso. Tra le strategie ci sono:
-
Accesso agli atti per acquisire tutta la documentazione utile;
-
Richiesta di consulenza tecnica di parte per individuare difetti di taratura o uso scorretto dell’etilometro;
-
Eccezione di nullità per vizi nella procedura (mancato avviso, assenza di doppia misurazione, irregolarità formali nei verbali);
-
Richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova o applicazione di lavori di pubblica utilità, quando previsti;
-
Valutazione della prescrizione del reato o della particolare tenuità del fatto.
Il ricorso avverso la sospensione della patente va presentato al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo. In ambito penale, è possibile opporsi al decreto di condanna nei termini previsti o, se necessario, valutare il patteggiamento. Tutte le strategie vanno calibrate sulle concrete evidenze raccolte e sulla documentazione tecnica acquisita durante la fase preliminare.
Tempi e fasi della procedura di ricorso
I tempi delle procedure possono variare sensibilmente in base alla complessità e alla sede del procedimento:
|
Fase |
Durata indicativa |
|
Presentazione ricorso amministrativo al Giudice di Pace |
Entro 30 giorni dalla notifica |
|
Fase istruttoria - acquisizione atti e consulenze tecniche |
Da 1 a 3 mesi |
|
Udienza di discussione e decisione |
Entro 6/12 mesi dalla presentazione del ricorso |
|
Opposizione decreto penale |
Entro 15 giorni dalla notifica |
Le tempistiche nei procedimenti penali risultano spesso più lunghe rispetto a quelli amministrativi, con l’eventualità di ricorsi in appello o in Cassazione nei casi più complessi. Sin dal primo momento, il supporto di professionisti esperti garantisce la corretta impostazione delle strategie difensive e la raccolta di tutta la documentazione necessaria a valorizzare le migliori possibilità di accoglimento delle istanze presentate.
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra