
Di chi è la responsabilità se il mio cane o gatto si ammala o muore quando è in una pensione per gli animali?
Chi è responsabile della morte di un cane o gatto che muore quando è in una pensione per animali: cosa prevede la normativa in vigore e le conseguenze
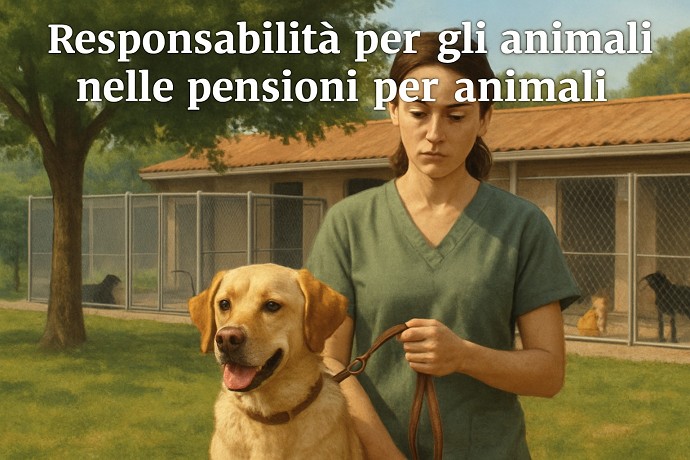
Un numero crescente di persone affida il proprio animale domestico a strutture specializzate durante periodi di assenza prolungata.
Questa tendenza, però, impone una riflessione attenta sulle responsabilità connesse all’affidamento degli animali da compagnia, in particolare in caso di malattia grave o decesso nelle pensioni.
Affidamento dell’animale a una pensione: natura del rapporto e obblighi
L'affidamento di un cane o gatto a una pensione rappresenta un rapporto contrattuale assimilabile a quello di deposito, disciplinato dal Codice Civile.
Il titolare della pensione, in qualità di depositario, assume l’obbligo di custodire l’animale, il che implica un insieme di doveri giuridici e pratici, come:
- Provvedere all’alimentazione e all’idratazione adeguate
- Garantire un ambiente salubre, sicuro e compatibile con le necessità etologiche della specie
- Attuare una vigilanza costante in relazione allo stato di salute dell’animale
- Adottare tempestivamente tutte le misure necessarie in presenza di sintomi sospetti o peggioramento clinico
- Comunicare tempestivamente al proprietario qualsiasi evento anomalo coinvolgente l’animale
Sussiste per i titolare della pensione o altra struttura in cui viene lasciato il cane o il gatto anche il dovere di prevenire situazioni di sofferenza e di adottare prassi che tutelino il benessere degli animali ospitati, come richiesto dalla normativa nazionale e regionale in materia di protezione animale.
Responsabilità civile e penale del gestore della pensione
Quando un cane o un gatto si ammala o muore in una pensione per animale è il gestore della struttura il responsabile e la sua responsabilità emerge sia sul piano civile che penale.
Sul versante civile, la mancata diligenza nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali implica l’obbligo di risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da condotte omissive o negligenti.
Il deposito di un animale, infatti, presuppone non solo la restituzione dell’esemplare nelle stesse condizioni di salute in cui è stato affidato, ma anche il diritto del proprietario di essere risarcito per eventi dannosi riconducibili a carenze gestionali. Dunque, emerge:
- La responsabilità patrimoniale: include il valore dell’animale, le spese veterinarie sostenute e ogni costo direttamente riconducibile al danno subito.
- La responsabilità non patrimoniale: il danno morale può essere riconosciuto laddove la morte o la sofferenza dell’animale incida su interessi affettivi e relazionali del proprietario, come ribadito da recenti pronunce giurisprudenziali.
Assumono rilievo penale le condotte che determinano abbandono o detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale, ingenerando gravi sofferenze.
Si configura in questi casi il reato di abbandono di animali, punito con arresto o ammenda. Il punto fondamentale è la vigilanza attiva: il gestore risponde penalmente se non interviene a fronte di segnali anomali nello stato di salute, o omette di allertare tempestivamente veterinari o proprietari.
I casi giudiziari: analisi delle sentenze e precedenti rilevanti
Si sono verificati recentemente numerosi casi in cui i gestori delle pensioni sono stati chiamati a rispondere sia civilmente che penalmente.
Esemplificativi, in questo senso, sono i recenti procedimenti conclusisi presso il Tribunale di Prato e quello di Gignod (Aosta). Nel primo caso, la morte di una cagnolina per disidratazione, nonostante prescrizioni veterinarie chiare, ha condotto alla condanna del gestore sia per risarcimento patrimoniale che morale, con una liquidazione complessiva di quasi 30.000 euro e la motivazione che la perdita avesse leso l’interesse costituzionalmente tutelato alla sfera affettiva del proprietario.
| Sentenza | Anno | Risarcimento riconosciuto |
| Tribunale di Prato n.51 | 2025 | Circa 30.000 euro totali |
| Tribunale di Aosta | 2022 | 670 euro (ammenda), 5.000 euro (risarcimento civile) |
Risarcimento del danno patrimoniale e morale per la perdita dell’animale
Il riconoscimento del diritto al risarcimento in caso di perdita dell’animale affidato a una pensione rimanda ad una doppia dimensione: danno patrimoniale e danno morale.
Sul versante patrimoniale rientrano il valore dell’animale nel mercato, le spese mediche e veterinarie, i costi sostenuti per la permanenza nella struttura e i rimborsi delle somme già corrisposte.
Il danno morale viene determinato secondo criteri di equità, valutando elementi come la durata del rapporto, l’intensità del legame e le circostanze del decesso. La recente giurisprudenza sottolinea che la prova del pregiudizio può essere fornita attraverso presunzioni e indizi (foto, testimonianze, documenti medici).
Non è necessario ricorrere a perizie specialistiche per dimostrare il grado di sofferenza, bastando una documentazione sufficientemente articolata del rapporto affettivo.
I risarcimenti vengono, quindi, riconosciuti per:
- Danno patrimoniale: prezzo di acquisto, spese per cure non somministrate, valore affettivo tradotto in costi comprovabili.
- Danno morale: sofferenza emotiva, turbamento dell’equilibrio affettivo familiare ed esistenziale, lesione della sfera relazionale protetta costituzionalmente.
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra

