
Abusi edilizi e sanatorie 2025, le recenti sentenze che faranno giurisprudenza in modo importante
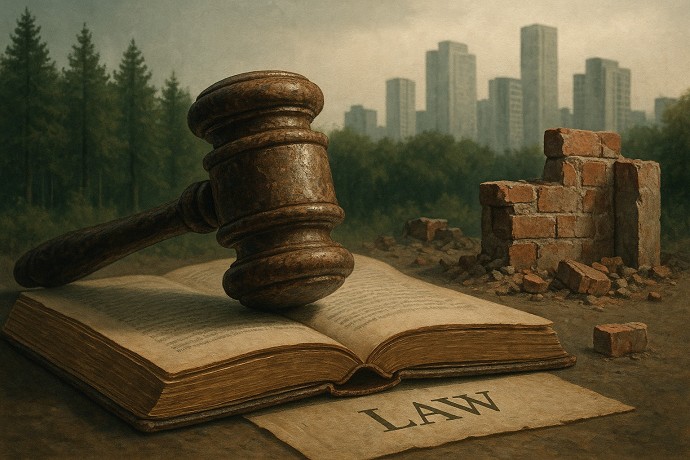
Abusi edilizi e sanatorie 2025: ecco le sentenze piů recenti che segnano nuovi orientamenti giurisprudenziali e possono cambiare le regole per molti immobili
Il panorama giuridico in tema di violazioni urbanistiche si arricchisce di importanti pronunce che nel 2025 segneranno l'evoluzione interpretativa della materia. La giurisprudenza recente ha definito nuovi parametri e criteri di valutazione che ridisegnano i confini tra l'intervento repressivo e la possibilità di regolarizzazione.
La valutazione proporzionale degli interventi demolitori secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, con una significativa sentenza del 2025, ha ridefinito le condizioni da considerare prima di procedere alla demolizione di un'opera edilizia non conforme. I giudici hanno stabilito che l'ordine di demolizione non può essere automatico, ma deve sempre essere preceduto da un'attenta valutazione della proporzionalità della misura rispetto ai diritti fondamentali delle persone coinvolte.
Secondo questo nuovo orientamento giurisprudenziale, prima di disporre la rimozione di un manufatto irregolare, le autorità competenti devono necessariamente considerare:
- La tipologia dell'immobile su cui è stato realizzato l'abuso (abitazione principale o secondaria)
- La rilevanza dell'abitazione per i soggetti che vi risiedono
- L'ubicazione geografica dell'immobile interessato
- Il grado di difformità rispetto alla normativa urbanistica
Va sottolineato che tale orientamento non legittima in alcun modo le violazioni urbanistiche, ma impone una valutazione caso per caso che consideri tutti gli interessi in gioco, inclusi quelli pubblici legati al rispetto della disciplina urbanistica.
I tre criteri fondamentali per le pertinenze secondo il Consiglio di Stato
Una recente pronuncia del Consiglio di Stato ha precisato i parametri per distinguere quando un manufatto possa essere considerato pertinenza in ambito urbanistico e quando, invece, costituisca una nuova costruzione soggetta a differente regime autorizzativo. La sentenza stabilisce tre requisiti essenziali per qualificare un'opera come pertinenziale:
- Assenza di incidenza sul carico urbanistico - Il manufatto non deve generare un aumento significativo del carico insediativo nell'area
- Assenza di autonoma destinazione - La struttura non deve poter essere utilizzata indipendentemente dall'edificio principale
- Assenza di modifiche sostanziali all'assetto territoriale - L'intervento non deve alterare significativamente la configurazione urbanistica della zona
- Modifiche volumetriche
- Alterazioni dei prospetti
- Cambiamenti nella destinazione d'uso dell'immobile
La sentenza stabilisce inoltre che, in assenza del necessario titolo edilizio, e qualora non si tratti di difformità parziali di modesta entità, l'unica soluzione applicabile è la demolizione, senza possibilità di ricorrere a sanzioni alternative.
Abusi edilizi in aree vincolate, il rigore della Cassazione
Un'altra importante pronuncia della Corte di Cassazione del 2025 ha affrontato la delicata questione degli abusi edilizi, come vengono trovati e sanzionati, anche di lieve entità, realizzati in zone soggette a vincoli paesaggistici. I giudici hanno adottato una posizione particolarmente rigorosa, stabilendo che in presenza di un vincolo paesaggistico non è mai ammissibile un'autorizzazione postuma per regolarizzare abusi edilizi, neppure se di modesta entità.
Questo orientamento si fonda sul principio secondo cui l'autorizzazione paesaggistica è intrinsecamente connessa al rilascio del permesso di costruire e deve necessariamente precederlo. Di conseguenza, in aree vincolate:
- Non è possibile ottenere una sanatoria urbanistica per opere realizzate senza autorizzazione
- Qualsiasi abuso, anche minimo, deve essere rimosso o demolito
- Le eccezioni sono ammesse solo nei casi specificamente previsti dalla legge
Tolleranze costruttive e piccole difformità, il nuovo approccio
La giurisprudenza del 2025 ha anche chiarito meglio i confini delle cosiddette tolleranze costruttive. Secondo recenti pronunciamenti, le difformità che rientrano nel margine di tolleranza (generalmente entro il 2% delle misure progettuali) non costituiscono violazioni edilizie e non necessitano di sanatoria.
Per le piccole difformità che superano tale soglia ma rimangono di modesta entità, i tribunali hanno riconosciuto la possibilità di applicare procedure semplificate di regolarizzazione, a condizione che:
- Non comportino violazioni di parametri urbanistici fondamentali
- Non alterino la sagoma o la volumetria complessiva dell'edificio
- Non compromettano requisiti di sicurezza strutturale o impiantistica
L'impatto del doppio binario sanzionatorio: penale e amministrativo
Un altro aspetto significativo emerso dalla giurisprudenza recente riguarda il rapporto tra sanzioni penali e amministrative in materia di abusi edilizi. Le sentenze del 2025 hanno confermato il principio del doppio binario sanzionatorio, chiarendo che:
- L'eventuale estinzione del reato edilizio (ad esempio per prescrizione) non preclude l'applicazione delle sanzioni amministrative, inclusa la demolizione
- La sanatoria amministrativa, quando ammissibile, ha effetti estintivi anche sul piano penale
- L'ordine di demolizione disposto dal giudice penale mantiene natura di sanzione amministrativa, con conseguente imprescrittibilità
Sanatorie e condono, i limiti invalicabili secondo la giurisprudenza
Le pronunce più recenti hanno anche definito con maggiore precisione i confini invalicabili oltre i quali non è possibile ricorrere a sanatorie o condoni. Secondo l'orientamento consolidato nel 2025, risultano assolutamente non sanabili:
- Opere realizzate in totale difformità dal titolo edilizio
- Interventi che comportano aumenti di volumetria in zone con vincoli di inedificabilità assoluta
- Manufatti che violano norme di sicurezza non derogabili
- Costruzioni che alterano in modo sostanziale aree di particolare pregio ambientale o paesaggistico
Leggi anche
- Quando un portico con abusi edilizi non sanabile nel passato puň ora essere sanato con il Decreto Salva Casa
- Terza Sanatoria, quali abusi edilizi si possono sanare e quali no in base a normative e molteplici sentenze chiarificatrici
- Fiscalizzazione di un abuso edilizio: quando la si puň ottenere per evitare demolizione. Procedura, costi, tempi, limiti
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra