
Alfabetizzazione degli italiani sempre peggio, uno su tre capisce solo un testo breve. Le conseguenze sul lavoro e occupazione
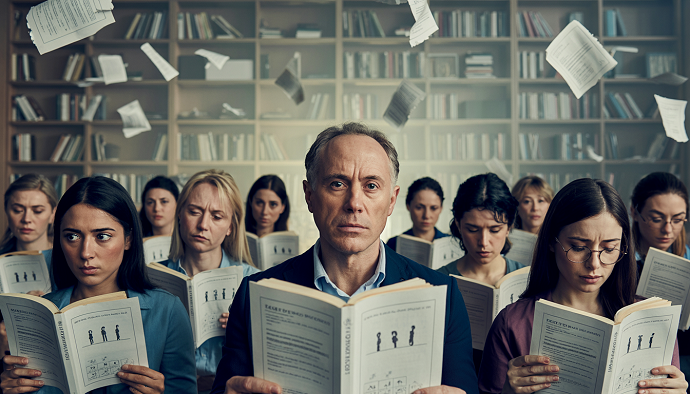
L'Italia affronta un declino dell'alfabetizzazione: uno su tre comprende solo testi brevi. Dati OCSE, cause storiche e sociali, impatto su lavoro, diseguaglianze e strategie sono al centro del dibattito.
L'Italia si trova dinanzi a un'emergenza silenziosa ma sempre più evidente: una percentuale rilevante di adulti manifesta gravi difficoltà nella lettura e nella comprensione di testi scritti. Le recenti indagini dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) hanno fotografato una situazione allarmante, dove circa un terzo della popolazione adulta riesce a comprendere solo istruzioni essenziali e testi molto brevi.
Questi dati pongono il Paese nelle ultime posizioni tra le nazioni avanzate per capacità di interpretazione e utilizzo delle competenze chiave, con ripercussioni dirette sulla società, sull'accesso alle opportunità e sullo sviluppo economico. Il fenomeno, indicato ormai come regressione delle competenze di base, mette in luce disuguaglianze profonde e la necessità di una strategia efficace per invertire la tendenza.
Che cos'è l'analfabetismo funzionale e come si misura in Italia
L'analfabetismo funzionale identifica la condizione di chi, pur sapendo leggere e scrivere, non riesce a comprendere un testo complesso né a utilizzare le informazioni apprese nella vita quotidiana. Questo concetto va oltre la semplice alfabetizzazione primaria, focalizzandosi sulla capacità di applicare le conoscenze per risolvere problemi, compilare moduli, seguire istruzioni e comunicare in modo efficace nel contesto lavorativo e sociale.
La misurazione dell'analfabetismo funzionale in Italia avviene attraverso indagini campionarie internazionali, come il Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) condotto dall'OCSE. Il PIAAC valuta tre aree fondamentali:
- Comprensione della lettura (literacy),
- Competenze numeriche (numeracy),
- Risolvere problemi in ambienti altamente informatizzati (problem solving adaptivo).
I dati OCSE: l'Italia agli ultimi posti in Europa per competenze di base
Secondo i dati diffusi dall'OCSE, la media italiana nei test di literacy si attesta a 245 punti, al di sotto della media dei Paesi coinvolti (260 punti). Analogo trend si riscontra nelle competenze matematiche, dove il punteggio medio nazionale è 244 rispetto alla media OCSE di 261. L'ambito più critico è il problem solving adattivo, con 231 punti contro i 250 della media internazionale. Questo è il quadro:
|
Competenza |
Punteggio Italia |
Media OCSE |
|
Comprensione del testo (literacy) |
245 |
260 |
|
Competenze numeriche (numeracy) |
244 |
261 |
|
Problem solving adattivo |
231 |
250 |
Ulteriori dettagli evidenziano una situazione di svantaggio rispetto ai Paesi più virtuosi come Finlandia, Norvegia e Svezia. In Italia il 35% degli adulti non va oltre il livello 1 nella comprensione del testo, contro una media OCSE del 26%. Solo il 5% raggiunge i livelli più alti di competenza, a fronte di una media internazionale del 12%. Simili disparità si osservano nelle abilità numeriche e nella capacità di risolvere problemi in contesti nuovi o digitali.
Questi risultati mostrano come molte persone, anche con titoli di studio medio-alti, non riescano a mantenere o potenziare nel tempo le competenze acquisite, probabilmente a causa di una scarsa diffusione della formazione continua e di una limitata abitudine alla lettura e all'apprendimento post-scolastico.
Le cause storiche e sociali del declino delle competenze
La regressione delle competenze di base in Italia affonda le sue radici in dinamiche storiche, sociali e culturali stratificate. Nel secondo dopoguerra, l'intensa urbanizzazione e il boom economico hanno favorito il passaggio da società rurale a urbana senza riuscire, tuttavia, a diffondere in modo omogeneo la cultura e la scolarizzazione.
L'elevato tasso di abbandono scolastico durante la crescita economica e la mancanza di strategie efficaci per la formazione degli adulti hanno lasciato un'eredità pesante nelle aree meno sviluppate. Anche riforme educative incoerenti e il progressivo impoverimento dei programmi formativi hanno concorso al fenomeno. Criticità aggiuntive emergono dall'insufficiente attenzione ai disturbi dell'apprendimento e alla carenza di investimenti pubblici in educazione, soprattutto a partire dagli anni '90.
Il risultato è un evidente divario tra le richieste della società attuale e le competenze realmente diffuse nella popolazione, con effetti immediati sulle capacità di partecipazione civile e lavorativa.
Le conseguenze dell'analfabetismo funzionale sul lavoro e sull'occupazione
L'insufficienza nelle competenze di base condiziona le possibilità di accesso, permanenza e qualità dell'occupazione. Una parte consistente della forza lavoro svolge attività per le quali il proprio livello di istruzione non trova pieno riconoscimento, come evidenziato dai recenti report internazionali: circa il 30% dei lavoratori nei Paesi avanzati non possiede le abilità indispensabili per la posizione ricoperta.
Le ripercussioni sono molteplici:
- Una quota di ingegneri, tecnici e laureati è impiegata in mansioni al di sotto della propria qualifica.
- I lavoratori sovraistruiti percepiscono mediamente stipendi inferiori del 12% rispetto a chi occupa ruoli allineati al proprio profilo professionale.
- La soddisfazione di vita risulta più bassa di circa 4 punti percentuali tra chi svolge mansioni non adeguate al proprio livello di preparazione.
- Più spazio per gli over 50 per via della maggiore qualità dell'istruzione ricevuta.
Le differenze tra generazioni, territori e background socio-economici
L'analisi mette in luce profonde disparità tra le varie generazioni, tra territori e tra persone appartenenti a differenti contesti socioeconomici:
- Gli adulti più anziani (55-65 anni) ottengono punteggi inferiori alle fasce di età più giovani (25-34 anni), segno di una scarsa qualità dell'istruzione ricevuta in passato e di una perdita delle competenze acquisite.
- Le diseguaglianze territoriali sono accentuate tra Nord e Sud Italia, con le regioni meridionali che registrano risultati ancora più distanti dalla media europea.
- Gli adulti nati all'estero mostrano difficoltà maggiori, mentre differenze di genere risultano trascurabili tranne che nel numeracy, dove gli uomini presentano risultati leggermente migliori.
La povertà educativa rappresenta uno degli ostacoli più gravi per la crescita socio-economica del Paese, influendo su mobilità sociale, accesso al lavoro e redistribuzione delle opportunità. Recenti analisi stimano che circa il 23,1% della popolazione sia esposta a rischio di esclusione sociale, con oltre un milione di minori in povertà assoluta.
Le condizioni di partenza incidono in misura significativa: laddove mancano investimenti nei servizi scolastici, nell'inclusione dei minori e nella formazione degli adulti, si osservano tassi più elevati di abbandono scolastico e skill mismatch nel mondo del lavoro. Le famiglie con basso livello culturale trasmettono difficoltà che si ripercuotono sulle scelte educative e lavorative dei figli, alimentando un ciclo di svantaggio difficilmente superabile.
La carenza di risorse umane qualificate condiziona la produttività complessiva e riduce il potenziale di crescita. Secondo le stime, il rafforzamento delle competenze diffuso potrebbe generare fino a 48 miliardi di euro aggiuntivi di prodotto interno lordo e ridurre il numero di persone escluse dal mercato del lavoro.
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra


