
Francia crisi del debito, Germania allarme pensioni... e l'Italia? Non sta certo meglio, anzi
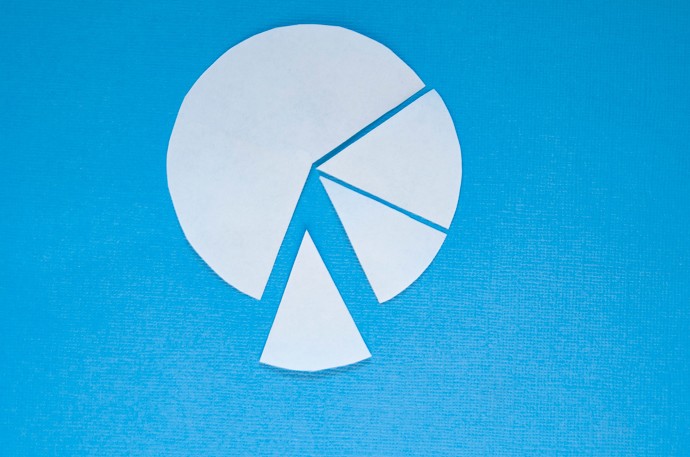
La fotografia d'insieme mostra tre Paesi chiave dell'eurozona accomunati da vulnerabilità diverse ma convergenti.
Il 2025 si apre con tre nodi che mettono in difficoltà l'economia dell'Europa continentale: la Francia alle prese con un disavanzo fuori controllo, la Germania che teme il collasso del suo sistema pensionistico sotto il peso della demografia, e l'Italia che nonostante una temporanea correzione dei saldi resta intrappolata in un debito elevatissimo e in una crescita insufficiente. Tre scenari distinti, ma legati dallo stesso destino: la necessità di rispettare le nuove regole europee di bilancio e dimostrare ai mercati la propria credibilità finanziaria.
Francia: il peso di un disavanzo che non cala
La Francia ha chiuso il 2024 con un deficit pubblico pari al 5,8% del PIL, un valore che non solo supera ampiamente il limite del 3% stabilito dai Trattati, ma che indica anche l'assenza di una traiettoria credibile di rientro. L'economia cresce a ritmi troppo deboli per sostenere una riduzione spontanea del disavanzo e la pressione sui conti aumenta in presenza di tassi di interesse più alti. In questo contesto il divario tra gli spread francesi e italiani, che solo due anni fa superava i 150 punti base, si è ridotto sotto i 10, un livello impensabile fino a pochi anni fa.
Sul piano politico, la fragilità dell'Assemblea nazionale complica ulteriormente la possibilità di varare misure impopolari di contenimento della spesa. Ogni tentativo di consolidamento fiscale rischia di essere paralizzato dalle opposizioni, in un contesto sociale già attraversato da tensioni sul costo della vita e sul mercato del lavoro.
Le agenzie di rating hanno iniziato a dare segnali chiari: S&P ha rivisto l'outlook della Francia a negativo, sottolineando che senza riforme serie i mercati inizieranno a chiedere un premio maggiore per continuare a finanziare Parigi. Se la fiducia si incrina, il costo del debito rischia di salire ancora, alimentando un circolo vizioso difficile da spezzare.
Germania: la bomba demografica e il futuro delle pensioni
La Germania si trova invece a fronteggiare un problema strutturale: il progressivo invecchiamento della popolazione e il buco da 30 miliardi di euro nel settore delle pensioni. Le coorti del baby boom vanno in pensione, mentre il numero di lavoratori attivi diminuisce. Secondo le stime ufficiali, entro il 2035 ci saranno oltre quattro milioni di pensionati in più, con un rapporto sempre più squilibrato tra chi versa contributi e chi riceve prestazioni.
Il governo ha promesso di mantenere il livello delle prestazioni al 48% del reddito medio, ma questo obiettivo implica un inevitabile aumento delle aliquote contributive: oggi ferme al 18,6%, potrebbero superare il 21% già nel prossimo decennio. Senza una crescita più robusta e senza un innalzamento dell'età effettiva di pensionamento, il peso della spesa previdenziale rischia di schiacciare sia imprese che lavoratori.
Berlino ha provato a introdurre il cosiddetto Generationenkapital, un fondo pubblico alimentato da risorse statali e destinato a investimenti finanziari per garantire rendimenti al sistema pensionistico. Si tratta di un passo avanti, ma le dimensioni del fondo restano limitate rispetto al fabbisogno complessivo. Un argine, insomma, che può ritardare l'impatto della marea ma non fermarla del tutto.
Italia: deficit sotto procedura e crescita anemica
L'Italia condivide con la Francia l'ingresso nella procedura per deficit eccessivo, decisa dalla Commissione europea nell'estate 2024. Il disavanzo si è ridotto rispetto all'anno precedente soprattutto per la fine degli incentivi edilizi straordinari come il Superbonus, che avevano gonfiato la spesa pubblica in modo eccezionale. Ma questa correzione non significa che i conti siano solidi: senza misure strutturali, il deficit rischia di risalire.
Il vero macigno resta il debito pubblico, che oscilla attorno al 135% del PIL. Anche con tassi in leggero calo rispetto ai picchi del 2023, il costo per rifinanziarlo rimane elevato e l'Italia deve generare avanzi primari consistenti solo per mantenere stabile il rapporto debito PIL. Ogni deviazione sulla crescita o sugli introiti fiscali può rimettere in discussione l'equilibrio.
Sul fronte della crescita, le stime per il 2025 sono deboli: intorno allo 0,6–0,7%, secondo le ultime valutazioni di istituzioni nazionali e internazionali in un contesto in cui gli stipendi sono bassi e il potere d'acquisto è in calo progressivo. La produttività rimane stagnante e l'unica leva di medio periodo resta il pieno utilizzo dei fondi del PNRR, che però sconta ritardi e difficoltà di implementazione. Senza un'accelerazione significativa sugli investimenti, l'Italia rischia di restare intrappolata in un equilibrio precario, dove il debito non scende e la competitività non cresce.
La fotografia d'insieme mostra tre Paesi chiave dell'eurozona accomunati da vulnerabilità diverse ma convergenti. La Francia combatte con un deficit cronico e una politica instabile; la Germania con il peso crescente delle pensioni e un modello economico meno competitivo; l'Italia con un debito che resta tra i più alti del mondo e una crescita incapace di sostenerne la riduzione.
In comune c'è la necessità di rispettare le nuove regole europee di bilancio, riattivate dopo la sospensione pandemica. A differenza degli anni passati, non ci sono margini illimitati: la Commissione e il Consiglio richiedono piani pluriennali di rientro credibili e monitorati, mentre i mercati, dopo anni di abbondanza monetaria, tornano a guardare con attenzione ai fondamentali.
Il rischio più grande è che la percezione di “non essere soli nella difficoltà” porti a sottovalutare la gravità della situazione. In realtà, la crisi di ciascun Paese rafforza l'instabilità complessiva dell'eurozona: se Francia, Germania e Italia non riusciranno a riformare i propri sistemi fiscali, previdenziali e produttivi, il prezzo da pagare sarà collettivo.
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra


