
Crescita economica Ue, Commissione taglia stime Italia +0,4% nel 2025 e +0,8% nel 2026. Poco meglio Eurozona
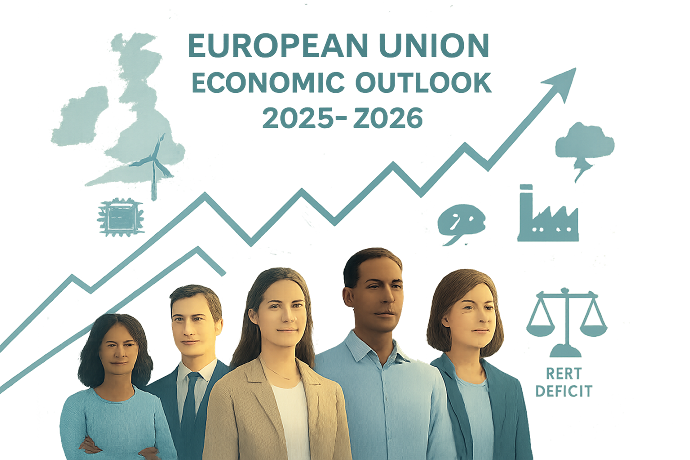
La Commissione europea rivede al ribasso le stime di crescita per l'Italia e l'Eurozona nel 2025-2026. L'analisi approfondisce impatti su deficit, debito, inflazione e fattori macroeconomici, confrontando i principali Paesi UE.
La Commissione europea ha diffuso oggi nuove valutazioni sullo scenario macroeconomico per l’Unione europea e per l’Italia, delineando un quadro caratterizzato da moderazione degli incrementi del Pil, in particolare per il nostro Paese. Le attese per il prossimo biennio segnalano una crescita contenuta, inferiore rispetto alle precedenti previsioni, sia per l’Italia sia per l’intera Eurozona, mettendo in luce elementi di debolezza strutturale e incertezza legati all’evoluzione internazionale.
Nel contesto delineato, le attese di crescita per i prossimi anni restano positive ma sottotono, e il confronto tra Italia e partners europei mostra differenze significative nella capacità di reazione e nelle performance previste, evidenziando la necessità di politiche convergenti e di rafforzamento della competitività.
Le nuove stime della Commissione europea: crescita in Italia e nell’Eurozona tra 2025 e 2026
Le previsioni autunnali della Commissione europea illustrano un ridimensionamento delle stime sia per il Pil italiano che per quello della media europea. Il Pil dell’Italia è atteso in crescita dello 0,4% nel 2025, in diminuzione rispetto allo 0,7% stimato nella primavera, e dello 0,8% nel 2026 (dallo 0,9% precedente). Questa revisione riflette le difficoltà nel recupero del ritmo pre-pandemico, accentuate dalla debolezza della domanda interna e dalle incertezze legate allo scenario internazionale e ai rapporti commerciali globlali.
Nell’Eurozona, dopo una ripresa dei primi tre trimestri del 2025 superiore alle attese (+1,3%), si prevede che il 2026 sarà caratterizzato da un incremento dell’1,2%, leggermente inferiore rispetto alle stime precedenti. Per l’intera Unione europea la crescita dovrebbe attestarsi all’1,4% nel 2026, segnalando quindi una differenza in positivo rispetto al dato italiano.
Il rilievo di queste proiezioni emerge anche nella prospettiva di medio termine: per il 2027 l’Italia si riconferma nella fascia bassa dei Paesi Ue per tasso di crescita, insieme alla Francia e alla Germania, mentre Spagna, Irlanda e Malta guidano il gruppo con performance più dinamiche. Gli investimenti sostenuti dal Recovery Fund e dal Fondo di coesione europea restano elementi centrali a sostegno della crescita, affiancati da misure strutturali e nuove riforme. Tuttavia, l’impatto positivo degli stimoli europei appare attenuato da un quadro di debolezza generale e da fattori esogeni che gravano sulle prospettive del commercio internazionale.
Il confronto tra le stime della Commissione e i dati inseriti nel Documento programmatico di bilancio del Governo evidenzia una tendenza comune al realismo: il governo stima lo 0,7% nel 2026 e lo 0,8% nel 2028, in linea con la visione di Bruxelles. In sintesi, se la zona euro mostra segnali di ripresa moderata, l’Italia si ritrova a fronteggiare sfide aggiuntive nel cammino verso una crescita più sostenuta e omogenea.
Deficit e debito pubblico: Italia, Eurozona e confronto europeo
Il tema della solidità delle finanze pubbliche rappresenta uno degli snodi principali nelle valutazioni europee. Nel 2025, il rapporto deficit/Pil dell’Italia è atteso al 3%, per scendere al 2,8% nel 2026 e al 2,6% nel 2027. Questi valori si collocano attualmente sotto le soglie di guardia indicate dai trattati europei, rispondendo agli impegni strutturali assunti dal Paese nell’ambito del nuovo Patto di stabilità.
I dati ufficiali delineano inoltre una progressiva diminuzione del disavanzo, confermata sia dal Documento programmatico di bilancio italiano sia dal confronto con altri partner dell’Unione. Per quanto concerne il debito, la Commissione europea prevede per l’Italia un indice in salita: dal 136,4% del Pil nel 2025, al 137,9% nel 2026, con leggera flessione al 137,2% nel 2027.
In una prospettiva comparata:
- Il debito della Francia è atteso sopra il 120% nel 2027;
- La Grecia dovrebbe mantenersi su valori intorno al 138%;
- Belgio e Spagna mostrano anch’essi dinamiche di indebitamento in crescita.
Le regole europee sul rientro dagli eccessi di deficit restano centrali, e le performance italiane degli ultimi anni stanno consolidando una maggiore credibilità presso i mercati e le istituzioni comunitarie.
Fattori e rischi che influenzano la crescita: geopolitica, commercio e clima
Numerosi elementi condizionano le prospettive dell’economia europea. La persistente volatilità delle relazioni internazionali rappresenta uno dei fattori più incisivi sul sentiment degli operatori economici. La Commissione europea segnala nella relazione autunnale che la fragilità delle politiche commerciali costituisce un rischio al ribasso per la crescita: dazi, restrizioni e incertezze sulle intese internazionali hanno potenzialità di incidere negativamente sulle esportazioni e sulla domanda aggregata.
In particolare:
- Tensioni geopolitiche crescenti – La possibilità di nuovi conflitti o di escalation nelle aree di frizione globale potrebbe alimentare shock di offerta e incremento della volatilità finanziaria.
- Clima di instabilità interna – La fiducia degli investitori risente anche dell’incertezza politica in alcuni Stati Ue e della frammentazione nei consensi, con possibili ricadute sulle condizioni di finanziamento.
- Cambiamenti climatici – L’incremento della frequenza e dell’intensità di disastri naturali minaccia la resilienza delle economie europee, richiedendo interventi strutturali e assicurativi più incisivi.
Inflazione, mercato del lavoro e andamento macroeconomico in Ue e Italia
Il profilo macroeconomico dell’Unione europea nei prossimi anni sarà caratterizzato da una dinamica inflazionistica in graduale riduzione e da una sostanziale tenuta del mercato del lavoro. L’inflazione media nell’eurozona, secondo le ultime stime Eurostat, scenderà all’1,9% già a metà 2025, per attestarsi sotto il 2% nel 2026; valori simili si prevedono per l’intera Ue. Tra le cause della discesa dei prezzi figurano l’abbassamento dei costi energetici e la parziale normalizzazione degli approvvigionamenti globali.
Per ciò che concerne il lavoro:
- Il tasso di disoccupazione nell’Ue è stabile attorno al 5,9%, con una discesa prevista fino al 5,7% nel 2026;
- Si stima la creazione di altri 2 milioni di nuovi posti nei prossimi due anni;
- In Italia, il tasso di occupazione resta stabile al 62,7%, secondo gli ultimi dati Istat.
Rimangono tuttavia forti le incognite su scala globale relative agli effetti dell’inasprimento delle condizioni finanziarie, in particolare negli Stati Uniti e nei Paesi emergenti. Nel complesso, la macroeconomia Ue presenta segnali di solidità, pur in un contesto dove la crescita rimarrà limitata e il percorso di rafforzamento dovrà essere sostenuto da politiche attive di lungo periodo, soprattutto in tema di produttività, innovazione e inclusione del mercato del lavoro.
Dinamica della crescita tra i principali Paesi Ue: Germania, Francia, Spagna e i Paesi trainanti
Le nuove stime della Commissione e dei principali istituti di ricerca mettono a confronto performance eterogenee nei maggiori Paesi europei. La Germania, principale economia del continente, mostra un profilo di “crescita piatta” nel 2025 (+0,4%) per poi accelerare leggermente (+1,2%) nel 2026, sostenuta dal rilancio degli investimenti infrastrutturali e di iniziative industriali pubbliche e private.
La Francia, invece, secondo Fitch, dovrà affrontare un aggravio del debito e una revisione al ribasso del rating, mentre le prospettive di crescita rimangono contenute nell’ordine dell’1-1,3% tra il 2025 e il 2026. La Spagna si conferma tra i Paesi più dinamici, trainando la media europea con una crescita superiore al 2% nei prossimi due anni, favorita dalla resilienza della domanda interna e da una maggiore diversificazione delle esportazioni.
Il quadro si completa con la performance di Irlanda e Malta, che mostrano i ritmi più elevati in termini di Pil, grazie all’integrazione nei circuiti globali delle economie digitali e dei servizi avanzati. Questi dati sottolineano la necessità per l’Italia di rafforzare l’attrattività per gli investimenti e l’innovazione al fine di recuperare il gap con i partner continentali, soprattutto replicando modelli basati su riforme strutturali e competitività globale.
Opportunità di crescita e settori chiave nel contesto europeo
Nonostante il rallentamento generale, il contesto europeo offre linee di sviluppo promettenti per chi saprà innovare e consolidare la presenza internazionale. Dai report di investitori istituzionali e market analyst europei emerge una convergenza sugli ambiti ritenuti più strategici:
- Tecnologia e semiconduttori (tecnologie abilitanti per data center, infrastrutture digitali, chip ed elettronica avanzata);
- Elettrificazione, energia e infrastrutture rinnovabili (spinta alla transizione energetica, investimenti nei trasporti puliti e infrastrutture digitali ottimizzate);
- Difesa e sicurezza, con un trend di crescita sostenuto dagli investimenti pubblici e dalla convergenza delle strategie tra i principali attori continentali;
- Banche con bilanci più solidi e valutazioni contenute, favorite dal miglioramento del quadro regolatorio e dal processo di consolidamento in atto.
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra


