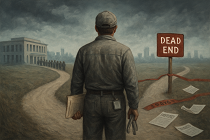Donne, il numero delle laureate in Italia supera i maschi e sorpasso arriverà anche sul lavoro, stipendi e potere

Le donne italiane superano gli uomini tra le laureate e puntano al sorpasso anche nel lavoro, stipendi e ruoli di potere. Unanalisi tra divario di genere, scelte formative, ostacoli e prospettive di crescita futura.
Il panorama dell’istruzione e del lavoro in Italia è testimone di una trasformazione significativa: ogni anno la presenza femminile tra i laureati cresce, superando costantemente quella maschile. I più recenti dati, inclusi quelli dell’ultimo rapporto AlmaLaurea, mostrano come la partecipazione delle donne all’istruzione terziaria e alla formazione superiore sia oggi ampiamente maggioritaria. Questo fenomeno, che nell’immediato si riflette soprattutto nel mondo accademico, prelude a uno scenario nel quale le donne si preparano a conquistare nuovo spazio anche in ambito lavorativo, retributivo e decisionale.
L’evoluzione del divario di genere nell'istruzione superiore italiana
L’istruzione terziaria in Italia ha vissuto importanti mutamenti negli ultimi decenni, modificando sensibilmente la distribuzione tra i generi. Oggi, sei laureati su dieci sono donne, e nelle lauree magistrali, la soglia sale a sette su dieci. Questa crescita è il risultato di un percorso iniziato negli anni Novanta, quando le donne hanno cominciato non solo a colmare il gap di genere nell’accesso alle università, ma a superare stabilmente la componente maschile. Il divario sta diventando sempre più evidente: se si pone la quota maschile a 100, in Italia quella femminile tocca quota 137.
Nonostante ciò, il nostro paese si mantiene al di sotto della media europea per presenza complessiva di giovani laureati (31% nel 2024 contro 43% UE fra i 25-34enni), con il dato maschile particolarmente basso: 24% contro il 38% europeo. La percentuale femminile, invece, tocca il 37% (contro 49% UE). Questa disparità risulta meno accentuata quando si analizzano esclusivamente le donne con titolo terziario, le quali evidenziano differenze di occupazione inferiori rispetto agli standard continentali.
L’aumento del numero di laureate influisce anche sui tassi di occupazione, riducendo gradualmente il gap di genere in linea con i dati europei: tra chi possiede solo la licenza media il divario occupazionale è di 22,7 punti, che scendono a 4,1 tra i laureati. Nel complesso, il livello di istruzione delle donne aiuta a ridurre le disuguaglianze di genere sia all’interno delle regioni italiane sia rispetto agli uomini. In particolare, il tasso di occupazione delle laureate è circa tre volte superiore rispetto a chi si ferma alla scuola dell’obbligo. Tuttavia, la percentuale di laureati, sia fra gli uomini che fra le donne, resta inferiore rispetto a molti altri paesi europei.
Scelte formative delle donne: percorsi liceali, università e area STEM
Le donne mostrano una netta preferenza per i percorsi liceali e universitari, con una marcata predilezione per le materie umanistiche, sociali e sanitarie. Circa il 65% delle studentesse sceglie il liceo, rispetto a una minore presenza negli istituti tecnici o professionali. Questo influenza le scelte universitarie, dove la maggioranza femminile si conferma soprattutto nelle discipline non tecniche.
I dati mettono in evidenza che solo una su cinque tra le giovani donne opta per i corsi STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica). La presenza femminile, in particolare, si attesta al 20% circa nei corsi STEM, mentre predilige settori come le scienze naturali (dove supera il 59% del totale), la medicina e l’area socio-sanitaria. Le ragazze italiane risultano mediamente più orientate rispetto alla media europea verso scienze naturali e matematica, ma sono ancora minoritarie in informatica, ICT e ingegneria.
Le ragioni di queste scelte si trovano nella combinazione di fattori culturali, aspettative familiari e stereotipi ancora radicati. Tuttavia, cresce lentamente anche la quota di donne che decide di affrontare percorsi tipicamente considerati “maschili”, come l’informatica e la tecnologia, in un lento progresso verso l’equilibrio di genere nelle aree tecniche.
In Italia il titolo di studio non basta: occupazione e disparità persistenti
Poter vantare un elevato livello di istruzione non significa necessariamente ottenere le stesse opportunità di inserimento occupazionale. Se da una parte il tasso di occupazione delle laureate cresce, le donne continuano a vivere condizioni più vulnerabili rispetto agli uomini: contratti precari, frequente ricorso al part-time involontario, salari inferiori e postazioni di lavoro meno stabili. Il gap si accentua ulteriormente in specifici territori come il Mezzogiorno.
Nonostante l’aumento del tasso occupazionale femminile negli ultimi 15 anni (+6,4 punti percentuali), l’Italia registra ancora una delle più elevate differenze di genere in Europa nella fascia 15-64 anni. Emerge una forte disparità tra Nord e Sud: se tra le donne laureate la forbice occupazionale tra queste aree si riduce, resta comunque di 14,5 punti.
Particolarmente sensibili sono le condizioni delle giovani lavoratrici, delle donne con titolo di studio basso e delle straniere, per le quali la precarietà contrattuale è più diffusa. Rispetto ad altri paesi europei come Germania e Francia, il tasso di occupazione femminile delle diplomate rimane molto distante, complice anche la scarsa valorizzazione delle lauree e la ridotta differenza retributiva rispetto ai diplomi.
Il gender gap nel mercato del lavoro: salari, carriere e rappresentanza ai vertici
Se nel panorama formativo il sorpasso c’è già stato, nel mondo del lavoro il cammino verso la parità è ancora lungo. Nel 2025, la differenza nei tassi di occupazione resta marcata: 71% per gli uomini, 53,4% per le donne. L’inattività femminile si attesta oltre il 42%, con un milione di donne che vorrebbero lavorare ma sono scoraggiate dalle basse prospettive e dai salari offerti.
La segmentazione di genere si riflette anche nella tipologia di contratti: il 30% delle donne lavora part-time rispetto al 7% degli uomini. Il gap retributivo medio si attesta attorno all’8%, ma nelle componenti variabili come i premi, la differenza supera il 25%. Le giovani laureate, inoltre, ricevono stipendi inferiori del 18,5% rispetto ai loro colleghi maschi. La differenza cresce con l’età, raggiungendo il 12% nella fascia 55-64 anni.
L’ascesa ai vertici rimane ancora poco accessibile: le donne rappresentano il 59% degli impiegati, ma solo il 35% tra i dirigenti e il 17% dei ruoli esecutivi nei consigli di amministrazione delle società quotate. In politica nazionale, la percentuale di deputate sfiora il 34%, mentre nei ruoli di governo scende al 29,7%. Sul territorio, i dati sono ancora più contenuti, con solo il 15% di sindaci donna:
- Barriere più visibili nei settori ad alta remunerazione: servizi finanziari, amministrazione, vendite e risorse umane registrano i maggiori divari retributivi.
- Occupazione dirigenziale femminile limitata: solo il 36% delle manager italiane ha un titolo di studio terziario, contro il 67% della media UE.
- Soffitto di cristallo nelle professioni apicali: tra i magistrati direttivi, solo il 28% sono donne, mentre si arriva al 58% tra i magistrati ordinari.
Ostacoli e opportunità: da maternità, stereotipi e carico familiare alle politiche di parità
Il percorso verso la parità nel lavoro è rallentato da diversi fattori strutturali e culturali. La maternità incide pesantemente sul tasso di occupazione femminile, soprattutto tra le madri con figli piccoli: tra i 25 e i 34 anni meno della metà delle madri risulta occupata, contro oltre il 60% nella fascia 35-54 anni. La difficoltà di conciliare responsabilità familiari e carriera incide ancora di più nel Mezzogiorno.
Le donne scontano un carico di lavoro domestico non retribuito mediamente triplo rispetto agli uomini. Gli stereotipi sui ruoli di genere sono ancora radicati, come confermato anche dalle più recenti indagini istat: il 23% degli uomini ritiene che il sostegno economico familiare spetti loro, percentuale doppia rispetto alle donne. Le politiche pubbliche mirate (servizi per l’infanzia, asili nido, incentivi alla contrattazione di secondo livello e promozione dei congedi parentali) sono essenziali per ridurre la disparità ma faticano a essere implementate in tutto il territorio nazionale:
- Scarsa partecipazione alle attività di formazione continua: in Italia la distanza dalle medie UE è ancora marcata, soprattutto per le donne adulte e in attività non qualificate.
- Insufficiente presenza nei settori STEM e negli incarichi apicali, conseguenza di scelte formative condizionate e di una carente cultura della parità.
- Politiche europee e italiane puntano dal 2024 a ridurre gli stereotipi, con obiettivi fissati dal Consiglio UE: raggiungere una presenza di laureati del 45% tra i 25-34enni entro il 2030, con la componente femminile già quasi al traguardo.
Come e perché il sorpasso arriverà anche su stipendi e potere
Le tendenze demografiche e le evoluzioni nei settori produttivi indicano che l’avanzata femminile nell’istruzione sarà destinata a riflettersi progressivamente anche sul mondo del lavoro, sugli stipendi e sul potere decisionale. L’incremento di donne laureate produrrà, nel medio periodo, una presenza crescente in tutte le professioni qualificate, con impatti positivi in termini di innovazione e produttività per l'intero paese.Le esperienze internazionali suggeriscono che paesi che hanno investito in servizi per l’infanzia e politiche di promozione della conciliazione hanno assistito a una crescita più veloce dell’occupazione e delle retribuzioni femminili. L’Italia mostra segnali di miglioramento, ma la trasformazione sarà vincolata dall’attuazione effettiva delle riforme su asili, congedi parentali, flessibilità dei tempi di lavoro e riduzione degli stereotipi. Nel lungo periodo, il maggiore capitale umano femminile non potrà che incidere per ridurre la disparità nei compensi e nei ruoli di vertice. Gli studi di settore indicano che, oltre agli effetti sociali, le imprese più diversificate presentano performance superiori.
La domanda di competenze avanzate e digitali sarà un alleato dell’avanzata femminile nei mercati emergenti e nelle carriere manageriali, accorciando sempre più il divario con la componente maschile fino a rendere il sorpasso nei ruoli di potere e negli stipendi non solo possibile, ma probabile nei prossimi anni.
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra