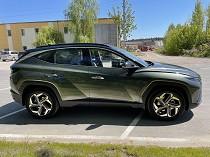Il grande business dietro agli affidamenti e ai figli tolti alla famiglie

Il principio cardine è che il minore ha diritto a crescere nella propria famiglia e che la semplice indigenza economica, come se parla già dal 2015 e di nuovo in auge con la vicenda della famiglia del bosco.
In Italia ogni anno decine di migliaia di bambini vengono allontanati dalla loro famiglia. Dietro ogni decreto del tribunale, ma se parla già dal 2015 e di nuovo in auge con la vicenda della famiglia del bosco, ci sono storie dolorose, errori, violenze, ma anche povertà, solitudine, fragilità educative. Accanto a questo, c’è una filiera di strutture, cooperative, consulenti, comunità, professionisti che attorno a quei bambini lavora, fattura, vive. È legittimo chiedersi se esista davvero un business degli affidamenti e dei figli tolti alle famiglie, o se questa espressione sia una semplificazione brutale che nasconde un sistema molto più ambiguo: fatto insieme di tutela e di rendite, di protezione necessaria e di zone grigie. I numeri parlano chiaro: 26mila ragazzi, 3000 comunità, 90 euro al giorno di rette.
Quanti bambini vengono tolti alla famiglia e perché
La colonna portante del sistema italiano è la legge 4 maggio 1983 n. 184, modificata dalla legge 149/2001: il principio cardine è che il minore ha diritto a crescere nella propria famiglia e che la semplice indigenza economica non può mai essere motivo di allontanamento. Solo quando il contesto è ritenuto “non idoneo” per maltrattamenti, abusi, trascuratezza grave, dipendenze, conflitti distruttivi, incapacità educativa il tribunale può decidere misure di protezione: affido familiare o inserimento in comunità.
Negli ultimi anni le rilevazioni coordinate dal Ministero del Lavoro e dall’Istituto degli Innocenti, aggiornate al 2022-2023, raccontano un fenomeno tutt’altro che marginale. Al 31 dicembre 2022 risultano, in Italia, 16.382 minorenni in affidamento familiare, comprensivi anche dei minori stranieri non accompagnati. Parallelamente, sempre per il 2022, il “Quaderno della ricerca sociale n.60” segnala 18.081 soggetti in comunità residenziale, al netto dei minori stranieri non accompagnati. Siamo nell’ordine di oltre 27 mila ragazzi fuori famiglia, una cifra che conferma quanto già indicato da precedenti report nazionali.
Se rapportiamo questi numeri alla popolazione minorile, parliamo di un tasso di allontanamento intorno al 2,5-3 per mille, considerato dagli esperti fra i più bassi in Europa. Questo non toglie che per ogni singolo bambino la misura rappresenti un terremoto affettivo, ma aiuta a ridimensionare l’idea di una macchina che “strappa” minori a raffica per fare cassa. L’allontanamento non è frequente in termini statistici, ma è certamente massiccio se guardiamo alle vite coinvolte, ai costi per i servizi sociali, ai fatturati delle strutture.
Il flusso di denaro: quanto vale il sistema tra rette, servizi e consulenze
Nel 2022 i Comuni italiani hanno destinato 10,9 miliardi di euro ai servizi sociali e socio-educativi; al netto dei rimborsi degli utenti e dei finanziamenti del Servizio sanitario, la spesa propria dei Comuni si attesta a 8,9 miliardi, pari allo 0,46% del Pil. Dentro questo grande contenitore rientrano molte voci: non solo minori, ma anche anziani, persone con disabilità, povertà estrema, ecc. Tuttavia, la tutela dei bambini e ragazzi fuori famiglia rappresenta una delle voci più costose e delicate, perché implica interventi h24, personale qualificato, strutture residenziali, percorsi educativi e terapeutici.
Le inchieste giornalistiche e le analisi di settore parlano chiaro: l’accoglienza in comunità per minori ha costi giornalieri molto elevati. Un recente approfondimento di Redattore Sociale stima una retta “teorica” di circa 151 euro al giorno per bambino, a fronte di rimborsi spesso inferiori riconosciuti dai Comuni; una comunità tipo può arrivare a costare oltre 440 mila euro l’anno.Altre analisi mostrano tariffe che vanno da 70 a 110 euro al giorno, con punte più alte in Veneto ed Emilia-Romagna, mentre le comunità familiari percepiscono 60–80 euro e le famiglie affidatarie un rimborso mensile fra 200 e 550 euro. In contesti come Roma e il Lazio, alcuni articoli segnalano costi di gestione per minore fra 261 e 285 euro al giorno, con una retta regionale che copre meno di 100 euro, lasciando alle strutture il compito di trovare ogni giorno circa 190 euro aggiuntivi per ospite.
Se facciamo un conto molto prudente, senza forzare i numeri, e ipotizziamo per gli oltre 18 mila minori in comunità una retta media effettiva di 100 euro al giorno, parliamo di circa 650 milioni di euro all’anno. Se la media reale, considerando alcune aree del Paese e i servizi aggiuntivi (educatori, psicologi, trasporti, ecc.), si avvicina ai 120–150 euro, il volume sale oltre il miliardo di euro. A questo vanno aggiunte le risorse destinate agli affidamenti familiari, ai servizi di tutela minori, ai centri diurni, alle perizie tecniche, alle supervisioni psicologiche, alla formazione degli operatori. In altre parole: intorno ai minori fuori famiglia ruota un settore economico molto rilevante, che interseca assistenza sociale, sanità, terzo settore e cooperative, con risorse pubbliche stabili e spesso pluriennali.
Profitti, conti in rosso e zone d’ombra
La narrativa del “grande business” fa pensare a margini di profitto altissimi e facili. La realtà, a guardare bilanci e testimonianze delle associazioni che gestiscono comunità, è più ambivalente. Molte strutture parlano di conti in rosso, di rette insufficienti a coprire il costo reale del personale, degli immobili, della formazione, della supervisione psicologica, delle attività extrascolastiche.Il problema, in questo pezzo del sistema, non è tanto la “speculazione sfrenata”, quanto piuttosto la sopravvivenza economica: ci sono enti che reggono grazie al volontariato, altri che compensano con altre attività sociali, altri ancora che, inevitabilmente, tagliano sui costi, con effetti potenzialmente pesanti sulla qualità dell’accoglienza.
Il giro d’affari esiste, ed è legato al fatto che l’accoglienza residenziale è una prestazione ad alta intensità economica garantita da fondi pubblici: se hai posti occupati, hai entrate certe; se hai posti vuoti, entri in crisi. Alcune inchieste giornalistiche hanno messo a fuoco il rischio di “cattura” del sistema: strutture che campano quasi esclusivamente di affidamenti, operatori che ruotano fra comunità e consulenze ai tribunali, cooperative che gestiscono sia i servizi sociali sia le strutture di accoglienza sul territorio. In questo intreccio di ruoli, se non ci sono controlli serrati, il confine fra bisogno reale del minore e interesse a mantenere alta l’occupazione dei posti diventa pericolosamente sottile.
Il rischio è che singoli casi di abuso, o di gestione opaca, vengano proiettati sul sistema intero, generando l’idea di una macchina costruita per “strappare” bambini alle famiglie per riempire le comunità. Alcuni scandali hanno dato carburante a questa visione, mostrando storie in cui il sospetto di conflitti di interesse e forzature nelle perizie è stato fortissimo. Ma le verifiche successive, sia giudiziarie sia istituzionali, hanno anche mostrato come non siamo di fronte a un meccanismo industriale di rapimento legalizzato, bensì a una somma di criticità, errori, talvolta reati, in un sistema fragile e scarsamente monitorato.
Chi guadagna e chi decide davvero
Quando un bambino viene allontanato, entrano in scena molti attori: servizi sociali comunali, tribunale per i minorenni, comunità o famiglia affidataria, spesso cooperative sociali che gestiscono i servizi sul territorio, psicologi e psichiatri, neuropsichiatri infantili, mediatori familiari, educatori, avvocati. Ogni intervento è una prestazione fatturata a qualcuno: al Comune, alla Asl, al tribunale. Questo non significa che tutti stiano “lucidando il bancomat”, ma è innegabile che le decisioni sulla vita dei minori muovono risorse, posti di lavoro, opportunità di progettazione.
La Commissione parlamentare di inchiesta sulle comunità per minori ha messo in luce, in audizioni e documenti, problemi strutturali: grande disomogeneità territoriale nelle tariffe, nel numero di ispezioni, nei criteri di accreditamento; difficoltà nel tracciare i percorsi dei bambini nel tempo; scarsa trasparenza su chi gestisce cosa e con quali controlli. In parallelo, diverse regioni hanno avviato proprie commissioni per verificare il funzionamento del sistema di tutela minori, registrando sovraccarichi dei servizi sociali, carenza di personale, formazione non uniforme, uso eccessivo dell’allontanamento rispetto al sostegno alla famiglia.
Il vero punto dolente, quando si parla di “business”, è il potenziale conflitto di interesse: situazioni in cui chi valuta, chi propone e chi esegue la misura appartiene, direttamente o indirettamente, alla stessa rete di cooperative o di strutture. In questi casi, anche senza mala fede, diventa più facile che la logica organizzativa pesi inconsciamente sulle valutazioni. È qui che il sistema mostra il fianco: non tanto in una cospirazione organizzata per rapire bambini, quanto in una filiera che non si è dotata di barriere sufficienti tra funzione di tutela, funzione gestionale e funzione di controllo.
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra