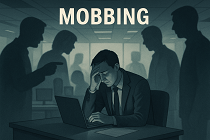In quali casi il demansionamento dà diritto al risarcimento in base sentenza Cassazione n.24133/2025

Quali sono i casi secondo cui si può ottenere un risarcimento per demansionamento al lavoro: cosa prevede la nuova recente sentenza della Cassazione
Nel contesto lavorativo italiano, il tema del demansionamento professionale riveste un rilievo considerevole sia in ambito individuale che giurisprudenziale. La Cassazione, con la sentenza n. 24133 del 28 agosto 2025, ha ribadito e affinato i principi che regolano l’assegnazione del risarcimento nei casi di trasferimento a mansioni inferiori, fornendo importanti chiarimenti per capire quando si può avere un risarcimento per demansionamento.
Cos’è il demansionamento: inquadramento normativo e implicazioni per il lavoratore
La normativa vigente sul demansionamento stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di adibire il dipendente alle mansioni per le quali è stato assunto o, eventualmente, a quelle corrispondenti a una qualifica superiore acquisita.
L’assegnazione a compiti di livello inferiore costituisce una violazione contrattuale, ledendo non solo l’identità professionale acquisita, ma anche il percorso di crescita e gratificazione previsto dall’ordinamento. Per comprendere meglio:
- Per demansionamento si intende il trasferimento, anche parziale e non dichiarato, a mansioni degradate rispetto all’inquadramento contrattuale
- Il lavoratore, in caso di inadempimento aziendale, può agire in giudizio per ottenere la riassegnazione alle proprie mansioni e, se necessario, il risarcimento delle conseguenze dannose subite
- La professionalità è considerata bene protetto sia sul piano patrimoniale che personale, coinvolgendo la dignità, il valore e le prospettive occupazionali del dipendente
| Norma di riferimento | Art. 2103 Codice Civile |
| Tipo di tutela | Reintegra, risarcimento patrimoniale e non patrimoniale |
| Beni protetti | Professionalità, dignità, salute |
Quando il demansionamento dà diritto al risarcimento secondo la Cassazione 24133/2025
L’assegnazione a mansioni inferiori non determina automaticamente il diritto al ristoro. Secondo la Corte di Cassazione, per avere diritto al risarcimento, è indispensabile dimostrare come la condotta del datore abbia inciso in concreto su aspetti patrimoniali o non patrimoniali.Inoltre:
- L’onere probatorio grava interamente sul lavoratore, il quale deve allegare elementi di fatto specifici, anche solo presuntivi, in grado di mostrare che il mutamento di mansioni ha prodotto una reale compromissione della propria professionalità, possibilità di crescita o condizioni di lavoro
- La semplice attribuzione a compiti inferiori non basta: occorrono indizi gravi, precisi e concordanti
- Sono oggetto di valutazione il tipo e la durata della dequalificazione, la qualità del bagaglio professionale eroso, la distanza tra le nuove e le vecchie mansioni e la mancanza di formazione adeguata.
Cosa deve dimostrare il lavoratore per ottenere il risarcimento
Il lavoratore che chiede il risarcimento per demansionamento deve presentare al giudice dati, indizi e documentazione che illustrino come lo spostamento di mansioni abbia in concreto generato un danno effettivo, indicando anche nel dettaglio:
- Durata e reiterazione della condotta: periodi prolungati e situazioni reiterate chiamano in causa una maggiore gravità del pregiudizio
- Qualifiche e competenze colpite: spostamenti che disconoscono il patrimonio di capacità acquisito sono valutati con particolare attenzione
- Effetti sulla carriera: interruzione o rallentamento delle possibilità di avanzamento e frustrazione di aspettative professionali
- Conseguenze personali: stress, perdita di autostima, disagio relazionale documentato, anche tramite certificazioni mediche per danno non patrimoniale
| Parametro | Rilevanza |
| Durata del demansionamento | Maggiore durata, maggiore danno potenziale |
| Competenze coinvolte | Impatto proporzionale alla specializzazione |
| Nuova collocazione | Più il nuovo ruolo è marginale, più aumenta la probabilità di danno |
| Mancanza di formazione | Assenza di aggiornamento aggrava la lesione |
Tipologia di danni risarcibili da demansionamento: danno patrimoniale e non patrimoniale
I danni che possono essere risarciti per demansionamento sono per legge:
- Danno patrimoniale: si riferisce alle perdite economiche dirette e indirette subite dal dipendente a seguito dell’inadempimento datoriale. Rientrano in questa categoria la perdita di chance professionali, il mancato avanzamento di carriera e l’impoverimento della capacità lavorativa spendibile sul mercato. Un impiegato privato delle mansioni di responsabilità, ad esempio, rischia di vedere deprezzato il suo profilo professionale, con probabile impatto sulle future opportunità di impiego e guadagno.
- Danno non patrimoniale: riguarda la sfera personale e la lesione di diritti tutelati dalla Costituzione (dignità, salute psico-fisica, immagine sociale). Rientrano in questa tipologia sia il danno morale, che si manifesta attraverso sofferenze interiori quali ansia e stress, sia il danno biologico, legato all’insorgere documentato di patologie psichiche derivanti dal peggioramento della posizione lavorativa.
La quantificazione del danno e la liquidazione equitativa secondo le pronunce della Cassazione
L’entità del risarcimento deve essere determinata in modo equitativo, valorizzando la specificità del caso concreto. Il giudice prende in considerazione una serie di elementi:- Il periodo durante il quale si è protratta la dequalificazione
- La gravità e notorietà del demansionamento in azienda
- La frustrazione delle legittime aspettative di progressione professionale
- L’eventuale isolamento lavorativo o perdita di professionalità aggiornata
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra