
Guida alla RITA, come andare in pensione anticipata con la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
La RITA, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, Ť una soluzione innovativa per il pensionamento anticipato in Italia. Requisiti, tipologie, vantaggi fiscali, procedure, gestione e il suo impatto sul sistema previdenziale
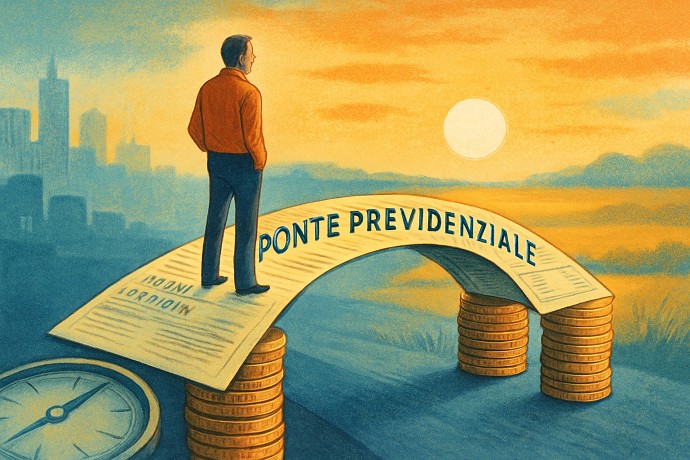
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è stata ideata per rispondere alle esigenze di chi intende anticipare l’accesso a un sostegno economico rispetto all’età ordinaria della pensione di vecchiaia. Si tratta di una modalità di liquidazione frazionata del capitale accumulato nei fondi pensione, destinata a colmare il periodo che separa la cessazione dell’attività lavorativa dal raggiungimento dei requisiti per il pensionamento ordinario.
In Italia, l'introduzione di questa forma di erogazione ha fornito un importante ponte previdenziale che non grava sul sistema pensionistico pubblico, ma si basa sull’accumulazione individuale presso forme di previdenza complementare. Tale soluzione rende possibile ottenere una rendita periodica, rateale, erogata direttamente dal fondo pensione dove l’aderente ha maturato il proprio montante contributivo. L’obiettivo è quello di offrire maggiore protezione finanziaria in una fase della vita spesso caratterizzata da instabilità lavorativa o difficoltà di reinserimento nel mercato occupazionale.
L’erogazione avviene nell’arco temporale che precede l’età pensionabile, risultando particolarmente utile per i soggetti che hanno perso il lavoro in età avanzata o per chi, avendo pianificato un percorso di previdenza integrativa, desidera accedere anticipatamente a parte delle risorse accumulate. Il meccanismo consente di integrare temporaneamente il reddito, senza impattare sulle casse dello Stato e promuovendo una cultura della pianificazione previdenziale autonoma.
Origine normativa e obiettivi della RITA
L’istituzione della RITA trova il suo fondamento nel Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, successivamente riformato con la Legge di Bilancio 2017 e resa stabile dalla Legge di Bilancio 2018. Il legislatore ha inteso introdurre questa forma di erogazione con l’obiettivo dichiarato di offrire ai lavoratori iscritti a forme di previdenza complementare un meccanismo flessibile e autonomo per gestire la fase di transizione tra cessazione dell’attività e pensionamento di vecchiaia.
L’inserimento della RITA nel quadro normativo della previdenza complementare si è sviluppato anche come risposta alle riforme pensionistiche che hanno innalzato l’età per il pensionamento pubblico, generando la necessità di uno strumento ponte capace di sostenere economicamente gli aderenti nel periodo privo di tutele pubbliche. Si tratta di un impianto pensato per favorire il ricorso alla previdenza privata, incentivando l’utilizzo delle risorse accumulate nel fondo pensione secondo criteri di autonomia individuale.
- Finalità di tutela sociale: garantire un reddito temporaneo in situazioni di inoccupazione o precarietà in prossimità della pensione;
- Incentivi alla previdenza integrativa: promozione del risparmio previdenziale per rafforzare la sostenibilità del sistema;
- Flessibilità gestionale: possibilità di destinare parte o l’intero montante, secondo le esigenze personali.
Chi può accedere alla RITA, requisiti e destinatari
L’accesso alla RITA è consentito a una platea definita di lavoratori iscritti a forme di previdenza complementare, in presenza di particolari requisiti anagrafici, contributivi e lavorativi. Il quadro dei destinatari è regolato dal D.Lgs. 252/2005 e dalle successive modificazioni normative, con criteri che puntano a garantire l’efficacia dello strumento nel soddisfare le esigenze di lavoratori prossimi all’età pensionabile.
- Iscrizione a un fondo pensione: l’aspirante beneficiario deve risultare iscritto a una forma di previdenza complementare da almeno 5 anni; un requisito ridotto a 3 anni esclusivamente per lavoratori che trasferiscono la residenza in un altro Stato UE dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
- Età e distanza dalla pensione di vecchiaia: la richiesta è ammessa se mancano meno di 5 anni al compimento dell’età prevista per la pensione pubblica di vecchiaia, nell’ambito del regime obbligatorio di appartenenza. Alternativamente, la RITA è accessibile anche da chi si trova a meno di 10 anni dalla pensione di vecchiaia e si trova in situazione di inoccupazione continuativa da almeno 24 mesi.
- Anzianità contributiva: è prevista la maturazione di almeno 20 anni di contributi nel sistema previdenziale pubblico solo per coloro che intendono accedere alla RITA con anticipo massimo di 5 anni rispetto all’età pensionabile.
- Settore di appartenenza: beneficiari sono sia lavoratori del settore privato sia pubblico, siano essi dipendenti, autonomi o iscritti a forme pensionistiche individuali e collettive. Sono invece esclusi i partecipanti a fondi preesistenti con prestazione definita che potrebbero alterare l’equilibrio attuariale delle gestioni.
L’accertamento dei requisiti avviene sulla base della normativa vigente al momento della domanda, con rilevanza sia dello stato lavorativo (cessazione, inoccupazione), sia dell’anzianità di iscrizione e contribuzione. Questo insieme di condizioni struttura una selettività mirata a garantire che il beneficio sia indirizzato effettivamente verso lavoratori in transizione tra attività e pensionamento ordinario.
Tipologie di RITA, totale e parziale
Il meccanismo della RITA consente una significativa flessibilità nella scelta della modalità di erogazione. Due sono le principali tipologie disponibili: totale e parziale. La distinzione riguarda la quota di montante accumulato nel fondo pensione cui viene applicata la rendita temporanea anticipata.
- Totale: prevede la conversione dell’intero capitale maturato presso il fondo pensione in erogazioni periodiche fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Questa opzione viene generalmente prescelta da chi desidera una continuità di reddito senza lasciare risorse residue nel fondo, garantendo la massima copertura economica nel periodo antecedente la pensione pubblica.
- Parziale: in questo caso, solo una parte del montante accumulato viene destinata alla RITA, mentre la quota restante rimane investita e disponibile per altre opzioni previdenziali. L’importo destinato a rendita viene quindi stabilito secondo le esigenze individuali, lasciando la libertà di effettuare ulteriori versamenti o di optare successivamente per altre prestazioni (anticipazioni, prestazione in capitale o rendita integrativa definitiva).
Entrambe le modalità sono personalizzabili nella misura della quota, consentendo agli iscritti un elevato grado di adattamento rispetto alle proprie strategie di pianificazione previdenziale.
Come funziona la RITA, modalità di erogazione e gestione
La procedura di erogazione della RITA si fonda su un meccanismo di liquidazione rateale che accompagna il beneficiario fino al conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. L’importo complessivo ammesso viene suddiviso in una serie di rate periodiche, generalmente mensili o trimestrali, la cui frequenza è definita dal regolamento del fondo pensione di appartenenza. Le modalità precise sono stabilite in funzione di una gestione amministrativa che garantisce trasparenza nella determinazione degli importi e nelle tempistiche di accredito.
- Durata dell’erogazione: la prestazione decorre dal momento di accettazione della richiesta fino al compimento dell’età anagrafica per la pensione pubblica, con capitale ripartito in base al periodo di tempo mancante.
- Quote investite: durante la fase di erogazione, il capitale residuo mantiene la propria posizione investita nella linea selezionata dal beneficiario (o, in assenza di scelta, nel comparto più conservativo). Prosegue quindi la maturazione dei rendimenti fino al progressivo disinvestimento per ciascuna rata.
- Personalizzazione: è consentita un’elevata flessibilità nella definizione dell’ammontare da destinare a RITA e nella possibilità di effettuare ulteriori versamenti mentre la prestazione è in corso.
Oltre all’accredito ordinario, la normativa ammette costi amministrativi applicati con ogni rata e prevede che la rendita possa essere erogata esclusivamente in modo frazionato (non in soluzione unica). La gestione amministrativa avviene seguendo regolamenti che garantiscono chiarezza comunicativa tramite prospetti periodici riepilogativi dei movimenti, delle singole erogazioni e delle condizioni applicate.
Procedure per la richiesta della RITA e documentazione necessaria
Il primo passo consiste nella compilazione di un modulo specifico, scaricabile dal sito del fondo o disponibile nell’area riservata online. Questo modulo deve essere completato accuratamente in ogni sua parte, indicando tra l’altro la quota di capitale da destinare alla rendita, i dati anagrafici e previdenziali e le coordinate bancarie per l’accredito delle rate.
- Documentazione obbligatoria: è necessario allegare alla domanda copia del documento d’identità e del codice fiscale. In alcuni casi, viene richiesta anche la documentazione che attesti la cessazione del rapporto di lavoro o l’inoccupazione protratta (ad esempio, il certificato del Centro per l’Impiego). Per accessi con requisiti contributivi, è indispensabile la documentazione INPS relativa alla posizione assicurativa.
- Modalità di invio: la domanda può essere inviata tramite raccomandata A/R, PEC (Posta Elettronica Certificata), o mediante presentazione diretta, ove previsto. L’utilizzo di strumenti digitali è ormai predominante per velocizzare le verifiche e agevolare il monitoraggio della pratica.
- Accertamento dei requisiti: il fondo effettua un’istruttoria per accertare la sussistenza delle condizioni e la correttezza della documentazione. La prestazione decorre dalla data in cui la richiesta viene formalmente accettata e la posizione viene liquidata secondo i termini previsti dal regolamento.
Compatibilità della RITA con altre prestazioni previdenziali e lavorative
L’erogazione della RITA presenta una ampia compatibilità rispetto ad altre prestazioni previdenziali e a possibili redditi da lavoro, secondo le indicazioni della circolare COVIP n. 4209/2020 e delle norme vigenti. Al momento della domanda, devono essere verificati i requisiti imposti dalla legge, ma l’inizio della percezione della rendita temporanea non impedisce il cumulo con altri trattamenti o il riavvio di un’attività lavorativa.
- Pensioni anticipate e pensioni di anzianità: la normativa consente il cumulo tra la RITA e le prestazioni pensionistiche pubbliche diverse dalla pensione di vecchiaia, come la pensione anticipata, quota 100, isopensione o opzione donna. In questi casi, la RITA può contribuire ad aumentare la disponibilità economica fino al compimento dell’età pensionabile ordinaria.
- Altre forme di accompagnamento al pensionamento: la prestazione si affianca all’APE sociale e all’APE volontario, e può essere richiesta anche in presenza di prestazioni come la NASpI se si verifica l’inoccupazione prevista dalla legge.
- Redditi da lavoro: una volta avviata la RITA, è possibile riprendere un’attività lavorativa sia dipendente che autonoma senza perdere il diritto alla prestazione già erogata, poiché i requisiti devono essere soddisfatti solo al momento della domanda.
Vantaggi fiscali della RITA e regimi di tassazione
La disciplina fiscale applicata alla RITA costituisce uno degli elementi di maggiore attrattività dello strumento rispetto ad altre prestazioni pensionistiche. L’aliquota agevolata è fissata di base al 15% sull’imponibile, con una progressiva riduzione dello 0,30% per ogni anno di adesione che eccede il quindicesimo anno, fino a raggiungere un minimo del 9%. Questa agevolazione si applica all’intero capitale erogato, inclusi i contributi versati prima del 2007, superando la distinzione in vigore per le prestazioni pensionistiche ordinarie.
- Aliquota flessibile: la percentuale di tassazione non si "cristallizza" al momento della richiesta di erogazione ma continua a decrescere se, nel corso della prestazione, si maturano ulteriori annualità di iscrizione.
- Soggettività di regime: il percettore può rinunciare al regime agevolato manifestando apposita opzione nella dichiarazione dei redditi e scegliere l’assoggettamento a tassazione ordinaria IRPEF, sfruttando le relative detrazioni previste per i redditi da lavoro dipendente (art. 13, TUIR).
- Tassazione dei rendimenti: i rendimenti finanziari generati dal fondo pensione durante la RITA sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 20%, inferiore rispetto all’ordinario 26% applicato agli altri strumenti di investimento.
L’insieme di queste regole fiscali valorizza la domanda di RITA come forma di prepensionamento "fiscalmente vantaggiosa" rispetto al TFR lasciato in azienda o ad altre forme reddituali, offrendo un ritorno più favorevole sulle somme liquidate agli aderenti.
Flessibilità e revocabilità della prestazione RITA
La struttura della prestazione della RITA si caratterizza per una notevole flessibilità operativa, sia in fase di scelta che durante l’erogazione. L’iscritto ha la possibilità di definire liberamente la percentuale di capitale da destinare alla rendita, modulando la misura della prestazione secondo le proprie esigenze di liquidità e strategia previdenziale. Questa libertà è ulteriormente rafforzata dalla facoltà di continuare ad effettuare versamenti aggiuntivi sul fondo anche durante la fase di erogazione.
- Revocabilità: la normativa riconosce il diritto di revocare la richiesta di RITA in qualsiasi momento. In caso di revoca, la parte residua del montante non ancora erogata ritorna presso il fondo pensione nella posizione individuale dell’aderente, senza perdita dei diritti maturati.
- Trasferibilità: l’aderente può anche optare per il trasferimento della posizione a un altro fondo pensione: l’eventuale trasferimento in corso di erogazione comporta automaticamente la cessazione della RITA.
Queste caratteristiche consentono una gestione dinamica della prestazione, adattandola facilmente alle variazioni personali o di mercato che possono intervenire nel corso del tempo.
Gestione del capitale e rendimenti durante l’erogazione della RITA
Durante l’erogazione della RITA, il capitale residuo continua a essere gestito in base alla linea di investimento selezionata dall’iscritto al momento dell’adesione al fondo pensione. In mancanza di indicazione, la posizione viene generalmente collocata nel comparto più prudente, caratterizzato da un livello di rischio contenuto e da obiettivi di stabilità del rendimento.
- Prosecuzione dei rendimenti: il montante non ancora liquidato prosegue nella maturazione dei rendimenti, con la possibilità di beneficiare di eventuali incrementi del valore delle quote nel periodo antecedente la liquidazione di ciascuna rata.
- Disinvestimento progressivo: a ogni erogazione, la porzione di capitale destinata a coprire la rata viene disinvestita, mentre la quota non ancora erogata resta investita. Questa modalità consente di mantenere in equilibrio tra opportunità di crescita e la necessità di garantire la liquidità necessaria alle scadenze periodiche.
- Gestione trasparente: i fondi pensione sono tenuti a fornire rendicontazioni dettagliate sulle performance del capitale e sulle operazioni di disinvestimento, tutelando così la piena trasparenza delle operazioni a favore degli iscritti.
Inoltre, l’aderente ha facoltà di modificare, ove consentito dal fondo, la propria scelta sulla linea di investimento anche durante la fase di percezione della prestazione.
Diritti degli eredi e casi particolari (decesso, trasferimenti, pignoramenti)
Nel corso dell’erogazione della RITA, possono presentarsi situazioni particolari che coinvolgono la posizione individuale dell’iscritto. In caso di decesso dell’aderente prima dell’integrale liquidazione della prestazione, gli importi residui spettano ai soggetti designati in polizza o, in assenza di indicazione, agli eredi legittimi secondo le regole di riscatto per premorienza previste dal fondo pensione.
- Trasferimenti: l’aderente può richiedere il trasferimento della posizione individuale presso altro fondo pensione durante la fase di erogazione. Il trasferimento comporta automaticamente la revoca della RITA e il montante non erogato segue il regime ordinario di accumulo e trasferibilità.
- Casi di pignoramento, sequestro o cessione: la protezione del capitale accumulato è regolata dall’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 252/2005, che prevede limiti alla cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità: tali operazioni sono consentite nei limiti di un quinto dell’importo, uniformandosi alle regole valide per le prestazioni di previdenza complementare.
- Ulteriori prestazioni: se la RITA è richiesta solo su una parte della posizione maturata, il residuo può essere oggetto di riscatti, anticipazioni o conversione in altra prestazione pensionistica secondo le regole previste dal fondo pensione e dalla normativa vigente.
L’applicazione di queste discipline rafforza la tutela del capitale destinato alla previdenza complementare, anche in presenza di eventi non ordinari.
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra


