
Il futuro dei nostri soldi? Siamo davanti a una svolta storica come lo era stata la caduta del muro di Berlino
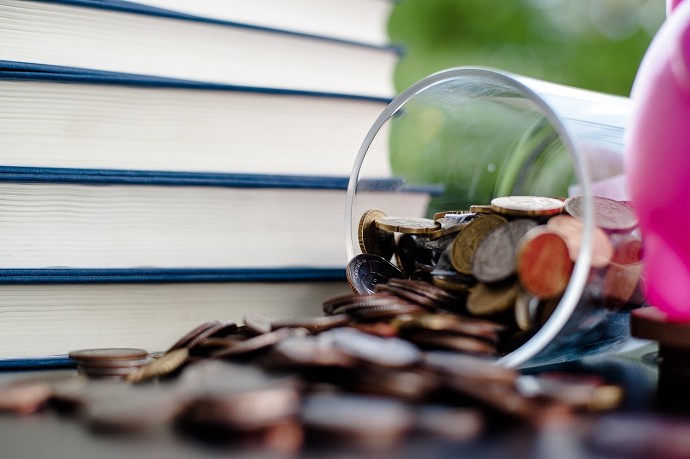
Nel breve termine, uno dei fattori chiave che stanno alimentando l'incertezza sui mercati Ť la questione dei dazi commerciali.
C'è un punto di svolta storico per l'economia globale, un momento paragonabile alla caduta del Muro di Berlino nel 1989. Come racconta il Wall Street Journal, a differenza di quell'evento simbolico, non ci sono state immagini drammatiche di folle che attraversavano posti di blocco armati. Questa volta, il cambiamento è più sottile ma non meno profondo e gli investitori stanno lottando per dare un prezzo a una realtà che sta evolvendo:
- La variabile dei dazi
- Nuove alleanze globali
- Il fardello del debito
La variabile dei dazi
Nel breve termine, uno dei fattori chiave che stanno alimentando l'incertezza sui mercati è la questione dei dazi commerciali. L'introduzione di tariffe su Canada e Messico, insieme a un altro 10% sulla Cina, sta creando un effetto domino nell'economia statunitense. L'impatto si traduce in un aumento immediato dei prezzi e in un'interruzione delle catene di approvvigionamento poiché molte aziende stanno tentando di riorganizzare le loro reti logistiche per evitare i costi aggiuntivi.Secondo Goldman Sachs, i dazi imposti su Canada e Messico potrebbero aggiungere 0,6 punti percentuali all'inflazione core negli Stati Uniti, senza cibo ed energia. L'aumento dei costi potrebbe avere ripercussioni non solo sui consumatori ma anche sulla produzione industriale, minacciando la crescita economica. La Federal Reserve si trova così in una posizione difficile: da un lato potrebbe decidere di tagliare i tassi di interesse per stimolare l'economia, dall'altro deve fare i conti con il rischio di un'inflazione crescente che limiterebbe la sua capacità di intervento.
Le banche centrali tendono a ignorare gli shock dell'offerta causati dai dazi e li trattano come eventi transitori. Se le aspettative di inflazione dovessero radicarsi tra consumatori e imprese, la Fed potrebbe essere costretta a mantenere una politica monetaria più restrittiva. Oggi il mercato sembra scommettere su una politica più accomodante, con le probabilità di almeno quattro tagli dei tassi quest'anno salite al 38%, rispetto al 4% di inizio mandato dell'ex presidente Donald Trump. Resta da vedere se la Fed sarà davvero disposta a tagliare i tassi in un contesto di inflazione crescente.
Nuove alleanze globali
A lungo termine, la vera sfida per gli investitori e per l'economia globale è la ricostruzione delle alleanze internazionali. La decisione degli Stati Uniti di allinearsi con Russia e Corea del Nord contro l'Ucraina alle Nazioni Unite ha inviato un segnale all'Europa e spinge il vecchio continente a rafforzare la propria autonomia militare. Politici europei, tra cui il cancelliere tedesco Friedrich Merz, hanno sottolineato la necessità di un'Europa forte e indipendente, capace di difendersi anche senza il supporto della Nato.
Questo cambiamento comporta non solo un aumento delle spese militari, con la Commissione Europea e la Germania pronte a mobilitare centinaia di miliardi di euro, ma anche una ristrutturazione economica e commerciale. Dalla fine della Guerra Fredda, l'Europa aveva privilegiato il burro alle armi, ossia la spesa per il welfare rispetto a quella militare. Ora, con l'ascesa della Cina e il deterioramento delle relazioni transatlantiche, le priorità potrebbero cambiare radicalmente.
Il passaggio a un'economia orientata alla spesa militare non sarà privo di controversie politiche e avrà costi elevati. I produttori di armi europei saranno tra i beneficiari mentre altri settori potrebbero soffrire per il calo dei consumi e per una nuova guerra fredda su più fronti. Con un mondo che si avvia verso un sistema multipolare, l'incertezza aumenterà e gli investitori dovranno fare i conti con un panorama geopolitico frammentato.
Il fardello del debito
Oltre ai dazi e alle nuove alleanze globali, un'altra variabile è il debito pubblico. I governi europei dovranno affrontare la sfida di finanziare la nuova spesa militare senza compromettere la sostenibilità fiscale. Negli Stati Uniti, la situazione non è migliore: il paese si trova su quella che viene definita una traiettoria fiscale insostenibile, con il debito pubblico che continua a crescere senza un piano chiaro per contenerlo.
Aumentare le tasse è una soluzione politicamente impopolare, mentre tagliare la spesa pubblica rischia di frenare la crescita economica. Un commercio globale meno efficiente, a causa delle barriere commerciali e dei dazi, renderà ancora più difficile mantenere il debito sotto controllo. La storia ha dimostrato che quando i governi accumulano troppo debito, gli investitori perdono fiducia, facendo salire i rendimenti obbligazionari e aggravando la situazione fiscale.
Durante la crisi dell'eurozona tra il 2010 e il 2012, e più recentemente nel Regno Unito sotto la breve leadership di Liz Truss, gli effetti di una politica fiscale avventata sono stati chiari. La soluzione adottata nel dopoguerra era stata la repressione finanziaria, mantenendo i tassi di interesse artificialmente bassi e limitando la possibilità per gli investitori di spostare i capitali all'estero.
Leggi anche
- Come insegnare la gestione dei soldi e del risparmio ai propri figli? Corsi online, libri e consigli utili (educazione finanziaria
- Come vanno le principali aziende italiane in base alle ultime trimestrali 2025 presentate ora a Novembre
- Rischi per piccoli risparmiatori: investire negli asset illiquidi. Quali sono e perchť sono pericolosi
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra

