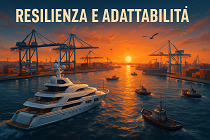Industria italiana, i problemi rimangono anzi aumentano. E continua il calo mentre si continua a discutere sul rilancio

Crollo dell'industria italiana tra dati Istat negativi, crisi nei settori chiave e nuove sfide globali come energia e guerre. Riflettori puntati su limiti strutturali e risposte della politica tra retorica e urgenze reali.
I dati diffusi dall'Istat evidenziano una riduzione della produzione industriale pari al 2,4% rispetto al mese precedente e al 2,7% su base annua. Questo brusco arretramento, che interrompe la debole ripresa osservata tra la primavera e l'inizio dell'estate, impone una lettura approfondita delle difficoltà strutturali che affliggono il settore. L'indice della produzione industriale si attesta ora a 91,6 (con base 100 fissata sul livello medio del 2021), un valore sensibilmente inferiore rispetto ai picchi pre-pandemici e addirittura più basso dei livelli registrati durante la pandemia.
Tale scenario, aggravato dall'assenza di restrizioni sanitarie, fa emergere quanto sia rilevante la tenuta del comparto industriale per il PIL nazionale, considerando che influisce direttamente su circa un quinto dell'intera economia italiana. Il protrarsi del calo da oltre due anni pone ulteriori interrogativi sulla capacità di ripresa e sulle reali prospettive dell'apparato produttivo, in uno scenario in cui il dibattito politico e le iniziative di rilancio sembrano faticare a trovare una direzione efficace e condivisa.
La crisi industriale: andamento e cause principali del declino
L'andamento negativo dell'industria italiana non può essere interpretato come un ciclo fisiologico, ma appare come un declino progressivo con cause molteplici e interconnesse. Dal febbraio 2023 si segnala un calo continuativo della produzione industriale, documentato da 26 mesi consecutivi di variazione tendenziale negativa. L'indice PMI (Purchasing Managers Index), autorevole riferimento per la temperatura economica delle imprese manifatturiere, si è mantenuto pressoché costantemente sotto la soglia dei 50 punti - sintomo di recessione - tranne rari e brevi rimbalzi:
- La domanda interna debole e una crisi di fiducia tra le famiglie, suscitate da incertezze macroeconomiche e inflazionistiche, hanno contratto i consumi di beni sia durevoli che non durevoli.
- L'export, tradizionale ancora di salvezza, ha tenuto solo parzialmente, ma risente delle difficoltà dei mercati esteri, soprattutto della frenata tedesca e della debolezza del partner francese, con cui l'Italia condivide complesse interdipendenze nelle filiere produttive.
- Le esportazioni verso Paesi extra-UE, in particolare gli Stati Uniti, sono ora gravate da dazi che penalizzano competitività e margini, mentre la Cina si rafforza come concorrente in settori strategici.
- Un altro elemento penalizzante è rappresentato dalla scarsità di investimenti mirati all'innovazione, alla digitalizzazione e alla trasformazione energetica, con un conseguente ritardo rispetto alle principali economie europee.
Settori in difficoltà: automotive, moda e manifattura
L'analisi per comparto mette in evidenza un quadro particolarmente allarmante. I problemi dell'industria italiana assumono una connotazione ancora più grave se si considerano i settori che maggiormente trainano il tessuto produttivo nazionale:
- Automotive: Il calo produttivo nel settore auto (inclusa componentistica e motori) supera il 19% nei primi nove mesi del 2024 rispetto all'anno precedente, con punte tendenziali superiori al 30% in alcuni mesi. Stellantis, principale produttore italiano, registra crolli delle vendite a doppia cifra e una sistematica riduzione della produzione negli stabilimenti nazionali. Le cause sono molteplici: una domanda interna stagnante, profonde modifiche nei comportamenti di consumo (noleggio, car sharing), una transizione difficile verso l'elettrico, prezzi in aumento e maggiore concorrenza cinese.
- Moda e Tessile: Il comparto abbigliamento-tessile-pelletteria, da sempre simbolo del Made in Italy, vive una fase di contrazione intensa: la produzione delle industrie della moda ha perso fino al 15% nei primi nove mesi del 2024, con forte riduzione degli ordini e Merce rimasta invenduta nei magazzini. Anche il comparto del lusso, solitamente più resistente, è ora in sofferenza, penalizzato da una fiammata inflazionistica e dalla frenata nei mercati internazionali chiave.
- Manifattura: La produzione manifatturiera in generale fa segnare un -8,7% rispetto a dicembre 2023. I mezzi di trasporto, il tessile, la metallurgia e la meccanica sono tra i comparti più colpiti, registrando cali a doppia cifra. Pochi sottosettori si sono salvati, come l'alimentare e la carta, ma il saldo complessivo rimane profondamente negativo.
L'impatto dei fattori esterni: costi energetici, guerre e dazi
Il contesto internazionale e le dinamiche esterne incidono sullo stato attuale del settore produttivo italiano. In primo luogo, l'esplosione dei prezzi dell'energia, innescata dallo stop al gas russo e dall'instabilità nei mercati internazionali delle materie prime, ha reso la produzione manifatturiera meno competitiva rispetto agli altri Paesi europei:
- Il costo dell'energia elettrica per le imprese nazionali è superiore dell'87% rispetto alla Francia e del 40% rispetto alla Germania (fonte: Confindustria 2024). Questo squilibrio, legato a tassazione, minore impiego di fonti rinnovabili e maggiore dipendenza dal gas, riduce notevolmente i margini delle imprese italiane.
- Le guerre in Ucraina e Medio Oriente aumentano l'incertezza e influenzano negativamente domanda e fiducia, rallentando la ripresa dei consumi e aggravando le tensioni sulle catene di approvvigionamento.
- L'applicazione di dazi statunitensi sulle merci europee, incluso il 15% sulle esportazioni italiane, mette a rischio un'importante fetta dell'export italiano, con effetti a cascata su produzione, investimenti e occupazione.
I limiti strutturali del modello industriale italiano
L'apparato produttivo nazionale porta con sé debolezze strutturali che aggravano ogni choc congiunturale. Una delle più evidenti resta la frammentazione delle imprese: il tessuto industriale italiano è dominato da piccole e medie aziende, spesso a conduzione familiare, concentrate in distretti produttivi che hanno garantito resilienza in passato, ma oggi manifestano limiti nel passaggio verso economia della conoscenza e dell'innovazione:
- Bassa produttività: Il lavoro dei settori industriali italiani, pur offrendo buona qualità, ha un tasso di innovazione e produttività inferiore rispetto alla media UE.
- Basso livello di investimenti: La difficoltà ad accedere al credito e la limitata propensione all'export impediscono spesso alle PMI di innovare processi e prodotti.
- Dipendenza da filiere internazionali: L'integrazione con la Germania e altri mercati rende molte filiere vulnerabili ai contraccolpi esterni.
- Costi elevati: Oltre al tema energetico, l'Italia registra oneri burocratici, fiscali e regolatori superiori alla media europea, rallentando sviluppo e competitività.
Le risposte politiche e le proposte per il rilancio: fra retorica e necessità
La gestione della crisi industriale da parte delle istituzioni è stata oggetto di frequenti critiche, sia per la scarsità di interventi strutturali sia per l'eccesso di retorica rispetto alle azioni concrete. Da oltre tre anni mancano misure ad hoc nella legge di bilancio, e molti provvedimenti sono rimasti inapplicati o inefficaci, tra cui la Transizione 5.0:
- I recenti annunci ministeriali sottolineano la necessità di una politica industriale europea più forte, in linea con le richieste di Confindustria, ma i risultati tangibili scarseggiano.
- Il cuore degli interventi si è spostato su provvedimenti di breve periodo, spesso focalizzati su incentivi alla domanda o alla riduzione dell'inflazione, anziché su investimenti strutturali nella competitività industriale.
- L'assenza di una visione chiara sui dossier strategici - come l'accordo UE-Mercosur o l'armonizzazione fiscale europea - priva le imprese di certezze sulle dinamiche future di mercato.
- Nell'ambito occupazionale, mentre aumenta la domanda di competenze specialistiche (es. meccatronica), le politiche di formazione e riqualificazione rimangono frammentarie e poco coordinate.
Leggi anche
- Che azienda č Leonardo? Chi sono i proprietari, cosa produce, le sedi, risultati finanziari e previsioni
- Perché Ferrero, Barilla, Esselunga e altre grandi aziende italiane non si quotano in Borsa? Una veritŕ importante
- Fagioli di Bud Spencer, vendite record. E ora arriva la birra e pizzone dall'azienda creata dal figlio e nipoti
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra