
Come trasformare una casa in un rudere per non pagare Imu e altre tasse. E lo fanno sempre più italiani
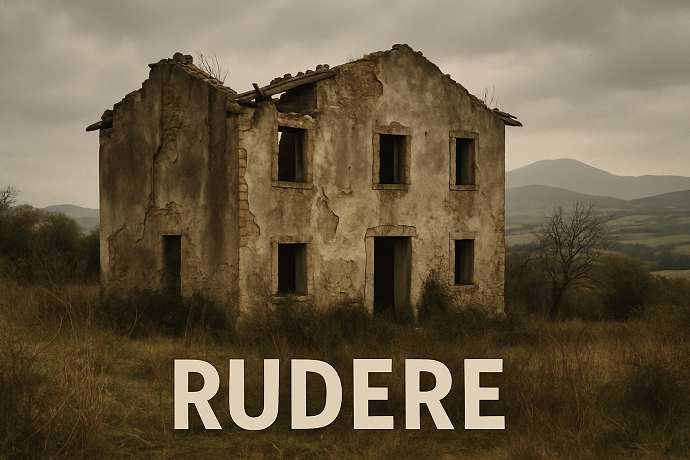
Come si trasformano le case in ruderi per non pagare l'Imu e sono sempre più gli italiani che abbandonano le seconde case per non versare le tasse
La trasformazione di immobili in stato di degrado, comunemente definiti “ruderi”, rappresenta una nuova tendenza in crescita. Negli ultimi anni, sempre più proprietari scelgono di lasciare decadere le proprie abitazioni, specialmente quelle ricevute in eredità o situate in zone rurali e periferiche, per trarne vantaggi economici rilevanti dal punto di vista tributario.
Perché trasformare una casa in rudere: esenzione IMU e norme fiscali
L’esenzione dall’IMU per immobili classificati come collabenti rappresenta una delle principali motivazioni che spingono molti proprietari ad avviare il processo di declassamento delle proprie abitazioni.
Dal 2012, in seguito all’introduzione dell’IMU, gli edifici iscritti alla categoria F2 non sono soggetti a tassazione poiché risultano privi di rendita catastale. Ciò significa che, non potendo produrre reddito né essere utilizzati per fini abitativi o produttivi, tali immobili vengono esclusi da qualsiasi imposizione IMU. Le norme fiscali vigenti prevedono:
- Immobili inagibili o inabitabili godono solo di una riduzione IMU del 50%;
- Immobili collabenti (F2) ottengono sempre l’esenzione totale, a patto che venga seguito il corretto iter di variazione catastale.
Come avviene la classificazione catastale F2: iter, requisiti tecnici e responsabilità
L’iscrizione di un fabbricato come rudere, nello stato di collabente nella categoria F2 non è automatica, ma prevede una precisa procedura tecnico-amministrativa. La categoria F2 viene attribuita dall’Agenzia delle Entrate su richiesta documentata del proprietario, che deve rivolgersi a un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra) per predisporre una perizia tecnica dettagliata sullo stato di degrado dell’edificio. I passaggi necessari sono i seguenti:- Relazione tecnica che attesti la mancanza di requisiti strutturali essenziali (assenza totale o parziale di copertura, crolli permamenti di parti portanti, assenza di impianti, infissi, servizi o collegamenti alle utenze).
- Documentazione fotografica comprovante lo stato di abbandono e inidoneità all’uso.
- Autocertificazione del proprietario riguardante la mancata allacciatura alle reti di acqua, gas, elettricità.
| Fase | Responsabile | Documento richiesto |
| Valutazione tecnica | Tecnico abilitato | Relazione tecnica dettagliata |
| Richiesta variazione catastale | Proprietario, tramite tecnico | Istanze e autocertificazioni |
| Verifica ed emissione provvedimento | Agenzia delle Entrate | Iscrizione a Catasto F2 |
Dati e tendenze: quanti italiani scelgono la strada dei ruderi e dove sono più diffusi
L’analisi dei dati ufficiali evidenzia un aumento significativo degli immobili classificati come "collabenti" negli ultimi anni. Dal 2011 al 2024, secondo le rilevazioni di Confedilizia e Agenzia delle Entrate, il numero totale delle unità immobiliari in categoria F2 è passato da circa 278.000 a oltre 629.000, con una crescita superiore al 126%. Questo trend si è intensificato soprattutto dopo l’introduzione dell’IMU, a testimonianza della correlazione tra politica fiscale e scelte dei proprietari. I dati recenti evidenziano che:
- Oltre 90% degli immobili collabenti è intestato a persone fisiche e si concentra in aree rurali o piccoli comuni;
- Tra le province con il maggior numero di ruderi spiccano Frosinone (32.000), Cosenza (23.300), Messina (18.800), Torino (16.100) e Cuneo (15.500);
- Nelle grandi città, il fenomeno è meno marcato ma in crescita, con Roma che registra quasi 5.800 fabbricati F2 e Napoli che, negli ultimi cinque anni, mostra l’incremento più rapido (+24%).
Le conseguenze e i rischi: abbandono, degrado, controlli e controversie
L’abbandono sistematico di abitazioni, incentivato dal regime fiscale favorevole per i ruderi, determina effetti rilevanti sia dal punto di vista sociale che urbanistico. Tra le conseguenze più significative:- Diffusione del degrado urbano e rurale, con impatto negativo sul valore delle aree circostanti e sulla sicurezza pubblica.
- Maggiore onere per i comuni, chiamati a gestire situazioni di incuria e potenziale rischio per l’incolumità delle persone.
- Incremento dei controlli da parte dell’amministrazione fiscale e dei comuni sulle dichiarazioni di inagibilità e sulle variazioni catastali.
- Possibili controversie legali, specialmente in caso di dichiarazioni fraudolente o in presenza di conflitti tra eredi.
Leggi anche
- Riscossione tributi locali (Imu, Tari, multe auto): nuovo ente AMCO per riscossione. Cosa cambia per i cittadini
- Imu e canone concordato: come pagare solo il 25% della tassa sulla casa affittata. Procedura, istruzioni, requisiti, calcolo
- Le tasse da pagare e adempimenti fiscali obbligatori da Settembre a Dicembre fino alla fine dell'anno
 Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra
Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra

